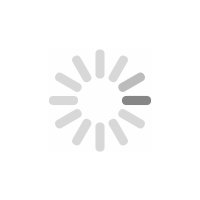C’è un motivo particolare nell’ospitare qui nel genio un così grande uomo, morto suicida all’età di 23 anni, nel 1910, dopo aver lasciato ai posteri non solo l’ardua sentenza - il dubbio e la colpa - del suo gesto estremo, ma anche l’opera fondamentale che porta il nome di “La Persuasione e la Rettorica” (1910). Il motivo particolare è che siamo in campagna elettorale, ed anche se non ne siamo pienamente consapevoli, ugualmente restiamo vittime dell’una, la persuasione, come dell’altra, la retorica. Certo con Michelstaedter parliamo di filosofia, ma non solo. Per il giovane laureando – l’opera era la sua tesi – la storia del pensiero è una storia di "rettorici" tradimenti, il succedersi di verità rivelate dai grandi "persuasi" agli uomini, che puntualmente le hanno lasciate disattesa e inascoltate. «Io lo so che parlo perché parlo ma non persuaderò nessuno…Eppure quanto io dico – scrive nella prefazione - è stato detto tante volte e con tale forza che pare impossibile che il mondo abbia ancor continuato ogni volta dopo che erano suonate quelle parole. Lo dissero ai greci Parmenide, Eraclito, Empedocle, ma Aristotele li trattò da naturalisti inesperti; lo disse Socrate, ma ci fabbricarono su 4 sistemi... lo disse Cristo, e ci fabbricarono su la Chiesa….Agli italiani lo proclamò trionfalmente Petrarca, e lo ripeté con dolore Leopardi». Può apparire complicato se letto oggi, quando la retorica ha totalmente sbranato la persuasione. Persuaso è colui che ha capito la tragicità della finitezza e da questa visione, benché dura, non vuole smuoversi. Il retore invece è chi getta fumo sulla consapevolezza del persuaso attraverso il divertissement, l’intrattenimento, diremmo oggi. Attualizzando, già viene in mente qualcuno. Cos’è la distrazione di massa se non l’operazione di un retore? E che fine può fare un persuaso se non sparire? (O trasformarsi in eretico, o in magistratura politicizzata, o parlare allo specchio). Non è un caso che Michelstaedter si sia tolto la vita. Dal punto di vista speculativo è stata una conseguenza meccanicistica. La sua breve vita un amaro postulato. Ovviamente i biografi sanno indicare motivazioni più terrene: nel 1909 si era suicidato il fratello Gino, due anni prima una donna che aveva amato, Nadia Baraden. Un suo amico, Rico, parte per l’Argentina, e Carlo si fa lasciare la sua pistola. Il 17 ottobre 1910, dopo un litigio con la madre, la prende e si spara. Sul frontespizio della tesi aveva scritto in greco: “apesbésthen”, “io mi spensi”. Michelstaedter ricorda Cesare Pavese, stessa sensibilità: era anche poeta e pittore, stessa fragilità sentimentale, medesima programmazione oltremondana: “verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Ricorda anche Ludwig Wittgenstein, nell’uso di una lingua plastica, viva, applicata a vette di delirio filosofico, prodotte nella prima metà del ‘900, poi sempre meno, perché la retorica ha vinto sulla persuasione. Ricorda l’autore del “Tractatus” (1922) - una delle più grandi menti di tutti i tempi, come viene presentato nella maggiore enciclopedia virtuale – anche per il terribile domino di suicidi familiari subìti. Michelstaedter però è un eroe, dimenticato, della Nazione. Lo conoscono solo gli iscritti delle Facoltà Umanistiche, o chi ha sfogliato il volume sul Novecento di Giulio Ferroni (cioè solo, tra gli iscritti delle facoltà umanistiche, quelli che studiano). Sono loro - i giovani - che devono vendicare Michelstaedter, i suoi perpetui coetanei ventitreenni, resuscitando la persuasione, che poi fa rima con passione, e soffiare finalmente via il velo triste del mercimonio della retorica, sotto cui c’è ancora, sepolto, un sorriso morente. (Valerio de Filippis)
(© 9Colonne - citare la fonte)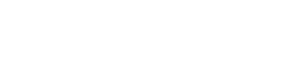



 amministrazione
amministrazione