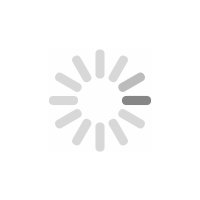Quando nel 2011 in Libia veniva abbattuto il regime di Gheddafi le immagini che arrivavano sui nostri teleschermi erano sconcertanti per chi era ancora abituato ad associare la guerra a grandi eserciti, grandi mezzi, grandi manovre. Ricordo un commento di mia madre, che osservava esterrefatta l’erratico andirivieni di qualche pickup scassato lungo strade costiere deserte su uno fondo di distruzione fumante, a bordo ragazzi armati senza divisa che salutavano le cineprese con l’allegria dell’incoscienza: “non avevo mai visto andare a fare la guerra in macchina”. Non è che non aveva mai visto immagini di guerriglia, e anche nella sua esperienza personale la guerra era stata sia grappoli di bombe sganciate dagli aeroplani sui grandi obiettivi, sia attentati e rappresaglie nel microcosmo locale. Intendeva: ‘come in gita’. Era lo stessa incomprensione che provavo anch’io, e che la mia laurea in scienze politiche non serviva a colmare, anzi faceva tacere.
Si ripete questa sensazione di incomprensione, che è diversa da quella di inaccettabilità morale, quando ci passano davanti agli occhi le immagini dei barconi che affondano sui nostri schermi, quando vediamo morire affogate quote di umanità di cui ignoravamo l’esistenza che perdono la vita e la dignità in diretta mentre stiamo cenando. Qualcuno, al riparo da qualche parte, li sta riprendendo per noi.
Per non parlare delle esecuzioni spettacolari, giocate sul contrasto cromatico-dimensionale: il boia grande ed eretto come una statua, ammantato di nero, astratto; la vittima inginocchiata, nuda come la sua disperazione dentro a un saio arancione.
Si è stabilito un inedito contrasto tra le immagini che circolano nei telegiornali - e noi vediamo solo quelle che circolano – e i fatti – di cui non sappiamo niente o quasi niente. Nell’informazione che ci arriva tramite la televisione sui conflitti alle porte di casa manca il raccordo tra l’esibizione della violenza e i risultati sul campo. Assistiamo in sequenza al lancio di un missile da una postazione a Donec'k da uomini che sembrano alle prese con un’esercitazione, e poi alle lacrime di una vecchia intabarrata in un villaggio sotto zero che piange morti che non vediamo. Quando viene menzionato l’ammontare dei morti nel sud-est dell’Ucraina (oltre 4000 in meno di un anno), sui civili presi in ostaggio in Irak o in Nigeria (centinaia alla volta) da parte dei gruppi jihadisti non capiamo di cosa stanno parlando, perché non li vediamo. E quando ci scorrono rapidamente davanti agli occhi immagini di campi profughi o di famiglie che fuggono a piedi con i borsoni in testa dai loro oppressori in Medio oriente proviamo quel lieve fastidio del déjà vu, come se si trattasse di una razza a parte, che è lì e così da sempre.
Del resto, in Italia le informazioni quantitative su questi stessi conflitti sono sempre limitate, disorganizzate e inferiori alle informazioni emotive, che vengono invece regolarmente trasmesse o ossessivamente ripetute. Per sapere quante sono le vittime della jihad (5000 in tutto il mondo solo nel mese di novembre) in quanti attacchi (664 in 14 paesi), come distribuiti (80% in Iraq, Nigeria, Siria e Afghanistan) occorre fare una ricerca, e per accorciare i tempi conviene andare direttamente sul sito di BBC, che svolge indagini in proprio o pubblica i risultati di fonti documentabili e affidabili. Essere laureati in scienze politiche e sapere l’inglese aiuta, cioè, ad ottenere informazioni che dovrebbero essere alla portata di tutti nelle fasce orarie di maggior ascolto della televisione, che è ancora il mezzo di informazione più accessibile e più utilizzato dalla popolazione non connessa (32%) e con basso livello di istruzione (60%). D’altra parte, anche la radio-televisione – quando trasmette dati - li attinge perlopiù da fonti estere, ad esempio la BBC. Altrimenti si sta senza. La RAI ha un solo ufficio e un unico corrispondente in Africa, basato a Nairobi. I suoi servizi speciali vengono trasmessi in Italia nel cuore della notte, coerentemente con la politica di segregazione dell’informazione di approfondimento nelle fasce orarie residue da quiz, cucina, meteo e talk show. Siccome non si può pretendere che sia ubiquo, quando deve riferire su quanto succede nell’Africa sub-sahariana fuori dal Kenia presumibilmente legge notizie di agenzia in inglese accessibili da dovunque. E così non sappiamo niente o quasi niente di quanto accade nel nord-est della Nigeria o in quello che rimane della Somalia.
Dall’altra parte, il fronte jihadista impiega le tecnologie digitali di rete in modo intensivo e consapevole come uno strumento di comunicazione, reclutamento, propaganda e (cyber)attacco non tanto a integrazione di altre risorse di guerra convenzionali ma come risorsa primaria. La guerra giocata con le tecniche dei videogiochi non fa meno vittime, ma confonde sulla reale identità dell’aggressore. L’attuale Stato Islamico (IS) ha cambiato denominazione tre volte nel giro di 2 anni in base alla sua localizzazione territoriale e in base alla competizione con altre organizzazioni qaidiste. Nasce nel 2006 come Stato Islamico dell’Irak (ISI), nel 2013 cerca di espandersi in Siria inglobando il Fronte al nusra nello Stato Islamico dell’Irak e del Levante (ISIL), ma la fusione fallisce e nel 2014 al Baghdadi rinuncia alla declinazione territoriale della sua sigla. Quello che rimane è la parola chiave (Stato) che è fondativa di un’identità fittizia: uno Stato che non è uno Stato, che non ha né continuità territoriale né un popolo di riferimento, né un sistema istituzionale di governo, ma solo un capo, che si autoproclama califfo. E’ un insieme di unità locali armate disseminate su una vastissima area mediorientale-nordafricana, nelle quali esercita un dominio instabile, che contende ad altre forze (eserciti regolari, curdi, altri gruppi jihadisti, ecc.), senza costruire un tessuto organizzativo strutturato. Qualcosa di molto diverso, ad esempio, da Hamas, che gestisce una vasta serie di servizi sociali ed è radicato nella popolazione della Striscia di Gaza.
Sempre tramite BBC (fonte Brookings Doha Center) si stima che in tutto il mondo i combattenti che militano nello Stato Islamico siano 31.000 (a ottobre 2014), di cui 18.000 stranieri. Per fare una proporzione, è un terzo della capienza del Wembley Stadium di Londra, che non è nemmeno lo stadio più grande del mondo. E’ ragionevole dedurre che si tratti di un fenomeno marginale, ad esempio rispetto al narcotraffico, se si pensa che solo in Messico il conflitto civile che si è scatenato tra i cartelli della droga e le forze armate del governo ha registrato 47.000 morti tra il 2006 e il 2012. La differenza sostanziale è che jihadisti e narcotrafficanti usano politiche di comunicazione opposte, che amplificano la debolezza dei primi, e avvolgono di ombra la magnitudine dei secondi.
Capita anche, però, che a volte le immagini trasmettano più informazione di quanto ci si aspetterebbe. E’ il caso del film Timbuktu, un capolavoro sia sul piano strettamente cinematografico, sia per la capacità di svelare la nudità del jihadismo e il funesto potenziale di violenza alimentato dalla stupidità. Un film che assolve magnificamente l’obbligo poetico dell’arte, un film che sussurra la verità senza rinunciare alla pietà, la cui ironia non ne fa mai scadere di livello la drammaticità. Ci sono telefonini dappertutto in questo film soffuso di silenzio e di polvere sabbiosa e tutti cercano risposte o conferme comunicando la propria incertezza. Anche per sapere che cos’altro interdire, oltre alla musica. Impariamo dal regista Sissako più di quanto i video-shock e i telegiornali non ci dicano, per fortuna.
(da mentepolitica.it)
(© 9Colonne - citare la fonte)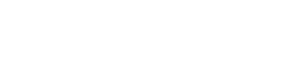



 amministrazione
amministrazione