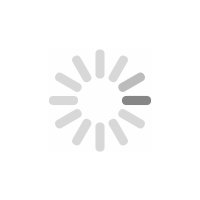“We face a war against Coronavirus”. A usare il termine “guerra” in relazione alle operazioni da mettere in atto per contrastare la pandemia è niente di meno che in un’intervista al Financial Times Mario Draghi, tra i più autorevoli governatori che la Banca centrale abbia mai avuto e tutt’ora considerato da molti come l’uomo della Provvidenza. Nell’uso del linguaggio guerresco Draghi è però in ottima compagnia, dalle cancellerie europee ai grandi media. Per uno storico dei conflitti come Marco Mondini, docente all’università di Padova, queste parole hanno un’eco molto profonda. “E’ un parallelo che ha colpito moltissimo tutti i miei colleghi di storia della guerra sparsi per il mondo, frequentando per mestiere quel codice retorico: c’è un comune ricorso a un lessico di guerra per rivolgersi ai propri cittadini da parte di quasi tutti i leader europei, tranne qualche eccezione tra cui la Merkel che nel discorso ai tedeschi si è limitata a dire che sarebbe stato il momento più difficile dalla Seconda guerra mondiale. La mobilitazione culturale è un fenomeno tipico delle società coinvolte in una guerra totale. L’obiettivo di questa mobilitazione è ottenere, organizzare e conservare il consenso”. “‘Siamo in guerra’, ‘ci mobilitiamo per la guerra’: la guerra è entrata nel vocabolario di tutti i giorni – aggiunge Mondini - c’è una ‘prima linea’ e una ‘trincea’, quella dei ‘combattenti’ che sono gli operatori sanitari con al loro fianco altre categorie come le forze dell’ordine o coloro che lavorano nei servizi essenziali. Questi combattenti di prima linea vengono contagiati in alte percentuali, muoiono e vengono celebrati con linguaggi e forme di ringraziamento collettivo non molto diversi da quelli usati durante una guerra, vengono chiamati eroi e celebrati facendo riferimento a un termine chiave, ‘sacrificio’. Quello di ‘sacrificio’ non è un termine neutro nel vocabolario della tradizione culturale europea, richiamando sia alla tradizione classica che a quella cristiana e che viene riattualizzato nel ‘900 in relazione al cittadino in armi che muore per il benessere della comunità. Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale i nostri Paesi si trovano di fronte a una morte collettiva presente nel quotidiano, perché anche il terrorismo colpisce una minoranza".
LA GRANDE GUERRA. Lo storico aggiunge, proseguendo nel parallelo: “Tutti i cittadini vengono mobilitati per combattere una guerra che è totale e dove ognuno ha il suo posto: chi è in prima linea deve combattere e noi dobbiamo fare altro, lavorare o semplicemente stare a casa. Di questo vocabolario paneuropeo e mondiale alcuni leader ne hanno fatto un uso esplicito, oltre al caso italiano quello francese è probabilmente il più eclatante. Nei suoi due discorsi ai francesi Macron ha citato esplicitamente due termini specifici legati non al linguaggio della guerra in generale ma al linguaggio della Prima guerra mondiale: ‘Union sacrée’ e ‘mobilitazione’”. Perché proprio la Grande Guerra, di cui di recente si è celebrato il centesimo anniversario? Secondo Mondini perché “sia in Francia che in Italia la Prima guerra mondiale è il momento ‘collettivo’ per definizione, la guerra del ‘900 che ha mobilitato tutto il corpo nazionale e che è stata vinta, perché la Seconda guerra mondiale nonostante lo sforzo retorico di De Gaulle ha visto una spaccatura e una guerra civile anche in Francia. E questo è uno dei motivi per cui nessuno istintivamente ha usato il termine ‘Resistenza’, perché sia in Francia che in Italia questo termine evoca il problema della guerra civile. Non solo la politica, anche i media si sono spontaneamente e immediatamente arruolati in tal senso.
IL LINGUAGGIO. Un linguaggio a cui sembrano non esserci alternative, che “soprattutto in Italia era stato estromesso dalla retorica pubblica almeno dagli anni ’60, anni a partire dai quali il nostro è diventato un Paese retoricamente demilitarizzato, a parte alcune metafore particolarmente efficaci come quella di Caporetto. Anche se – riconosce Mondini - un linguaggio di guerra è stato riattualizzato negli ultimi 20 anni parlando dei problemi legati alla sicurezza e al terrorismo. Ma per 50 anni la cultura europea ha fatto di tutto per estromettere la guerra, le armi e la violenza dal linguaggio e dell’immaginario: all’inizio del XXI secolo in tutta Europa viene cancellata di fatto l’ultima eredità della Rivoluzione francese che è il servizio di coscrizione obbligatoria. Alle spalle c’è la Seconda guerra mondiale, un trauma collettivo sia per i vincitori che per i vinti che spezza la linea della storia. Gli europei le guerre continuano a farle ma le chiamano in altri modi, missioni di pace o di stabilizzazione”.
QUALE CITTADINO? Ma allora, perché torna il linguaggio guerresco? “Il modello di cittadino europeo costruito dai tempi della Rivoluzione francese è un modello di cittadino sacrificale, che riconosce il privilegio di far parte di una comunità politica quale la nazione e che in cambio di questo privilegio assicura la propria disponibilità al sacrificio in armi per difenderla. Dal 1945 il rapporto tra cittadino e Stato in Europa cambia radicalmente nel modello del cittadino-consumatore, che non è più disposto ad assicurare il sacrificio della sua vita per la comunità di cui fa parte, a cui chiede fondamentalmente benessere e in cambio può restituire in termini economici di tasse e di consumi. Il rapporto tra cittadino e Stato si è progressivamente spostato dall’idea del sacrificio necessario a quella del benessere e del consumo. Il problema è che tutto questo funziona bene in una società non solo pacificata – in cui le guerre le fanno i professionisti – ma anche fin quando ai cittadini non venga richiesto imperativamente di limitare le proprie libertà e di sottoporsi a un controllo molto stringente della propria sfera individuale. Gli Stati europei per la prima volta oggi chiedono a tutti di reprimere la propria libertà individuale e per farlo devono mobilitare un linguaggio che consenta di capire come questo sia necessario, e certamente non possono farlo appellandosi al vocabolario del consumatore. Non esiste un altro vocabolario delle emozioni se non quello di guerra per convincere gli europei della necessità di sacrificarsi. È stata una sorpresa per tutti, sia nella sostanza che nel modo spontaneo in cui politici e mass media hanno aderito a questa scelta, non c’è stato nemmeno bisogno di una linea editoriale”.
E IL DISSENSO? Mondini sottolinea inoltre come “uno degli aspetti dell'utilizzo del linguaggio di guerra sia il suo successo nel mobilitare una comunità compatta dietro il leader. Naturalmente è presto per giudicare l'efficacia di questa unione sacra però pare che lo scopo di disciplinare le società e spegnere il dissenso sia, nel breve periodo, raggiunto. Un parallelismo più inquietante è che, come la guerra rende più coese le comunità ma accelera anche l'espulsione dei soggetti non allineati, così anche in Italia si è avuta una deriva in tal senso. Oltre ai combattenti di prima linea (medici, infermieri) e agli eroi (chi si è sacrificato in servizio per proteggere la comunità), abbiamo avuto anche i ‘disertori’ (chi ha cercato di violare la quarantena delle zone rosse: deprecabile naturalmente) e i ‘nemici interni’, con forme di delazione (a volte spontanee a volte promosse dalle amministrazioni locali) per chi non rispetta le norme sul contenimento del virus. Come sempre, però, non bisogna esagerare con comparazioni troppo semplicistiche”. Mondini, infatti, tende ad escludere il rischio che questa situazione eccezionale produca dei rischi per l’ordine democratico: “Non vedo all’orizzonte alcun desiderio di pressione autoritaria prendendo spunto dalla mobilitazione emergenziale delle società per il Coronavirus, mentre in Italia dopo il 1918 c’erano forti resistenze a smantellare gli apparati emergenziali per dare vita a nuovo tipo di Stato nazionale. Nel 1915 le leggi eccezionali sospesero il diritto di circolazione, di assembramento e misero la censura sulla stampa: già questo ci suggerisce che si parla di provvedimenti di ordine differente, nessuno oggi ha pensato di mettere il bavaglio all’informazione che anzi oggi è diventata ancora più importante. In nessun Paese europeo il varo di queste norme emergenziali è stato sottratto al controllo dello Stato di diritto. Anche se non metterei la mano sul fuoco sui Paesi di Visegrad".
L’EUROPA. Cruciale resta il problema dell’Europa: “Il Coronavirus – sottolinea lo storico - è una sfida capitale per la Ue, che soffre di un deficit di identità politica e di capacità decisionale. Non sono uno storico dell’economia né un esperto di istituzioni europee, ma si deve accendere anche qui una riflessione sull’uso del linguaggio fatto dalle istituzioni europee che hanno commesso una serie di gaffe madornali, dalla Lagarde alla Von Der Leyen: in una situazione di crisi, dipinta con i tratti della guerra, una cosa imperdonabile sono gli errori di comunicazione perché seminano il panico e aumentano i danni, oltre che il desiderio di molti cittadini europei di smarcarsi dall’accettazione disciplinata di questi sacrifici. Credo fortemente che una crisi pandemica come quella che stiamo vivendo, globale per definizione, non possa essere né affrontata né risolta a livello di stati nazionali. Le pandemie non conoscono confini, né interni né esterni alla Ue. La soluzione della crisi pandemica può essere una grande opportunità per la Ue, che però deve coglierla e deve farlo molto in fretta. Servirebbe un forte coordinamento centrale dell’Unione, una condivisione delle risposte prima a livello di politiche sanitarie che economiche. Se la Ue dovesse perdere questa occasione la prospettiva sarebbe abbastanza nefasta”.
IL “DOPOGUERRA”. Dopo la pandemia nulla sarà più come prima? “Oltre che uno storico della guerra sono uno storico dei dopoguerra – afferma Mondini –. Ho notato anche in questo caso l’uso di un linguaggio millenaristico tipico di ogni guerra mondiale. In altre parole, coloro che vivono una straordinaria prova di sofferenza e sacrificio si convincono che il mondo di domani sarà diverso e magari migliore. Ok se questo è uno strumento psicologico a cui si ricorre per non crollare, ma in questa espressione ‘nulla sarà più come prima’ vedo una ricorrenza del linguaggio millenaristico della Grande Guerra, che mi spaventa un po’ non tanto per fantomatiche tentazioni autoritarie ma perché può succedere esattamente quanto successo dopo il 1918: cioè una clamorosa ondata di delusione e di traumatico ritorno alla realtà. Conviene concentrarsi sui problemi concreti da risolvere più che vagheggiare un improbabile mondo migliore”. (Roberto Calabria – 30 mar)
(© 9Colonne - citare la fonte)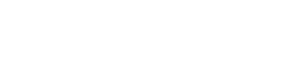



 amministrazione
amministrazione