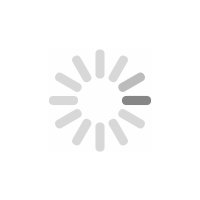Alla Farnesina è in corso l’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all’estero. Oggi si parla di informazione e comunicazione: un mondo – quello dell’editoria – in profondo cambiamento. Ecco l’intervento di Paolo Pagliaro al convegno sull’informazione, organizzato nell'ambito dei lavori della sessione plenaria del Cgie.
Non è un momento particolarmente felice per chi fa il mestiere del giornalista. Non lo è per almeno 3 ragioni. La prima è che il nostro mestiere sembra diventato superfluo nell’era della disintermediazione digitale. Ciascuno di noi è diventato cronista, fotografo, editore, comunicatore e lettore. Il giornalismo come professione è considerato non più lo strumento che consente di avvicinarsi alla realtà, di approfondirla e di comprenderla meglio ma un filtro che la deforma e la piega a interessi che nella nuova narrazione sono quasi sempre oscuri. In passato i giornalisti avevano il potere esclusivo di portare la gente in luoghi dove non era mai stata. Oggi chiunque possieda un videotelefono può mostrare a tutto il mondo ciò che accade intorno a lui. E’ un grande progresso che nasconde una grande insidia. Perché abbiamo sì tanti volti e frammenti di realtà, ma come i frantumi di uno specchio andato in mille pezzi nessuna di queste immagini riesce da sola a darci un’idea del mondo, a dirci che direzione abbia preso e quale sia la meta.
Una seconda ragione della crisi del giornalismo è il declino dell’industria editoriale tradizionale, piegata dalla concorrenza della rete e dei social media in particolare. Negli ultimi dieci anni le copie vendute sono diminuite del 50% e il fatturato pubblicitario del 60. Dall'ultimo rapporto Censis sulla spesa delle famiglie per consumi mediatici risulta che le spese per smartphone sono esplose del 190%. Un nuovo “duopolio” straniero (Google e Facebook) controlla oggi oltre il 70% del fatturato pubblicitario internet, che a sua volta rappresenta un terzo del totale. Sul mercato pubblicitario in dieci anni le posizioni di stampa e internet si sono invertite: la prima è passata dal 31% al 13%, mentre il web dal 10% è cresciuto al 34%.
Un mestiere che rischia di tramontare insieme a media tradizionali come i giornali. Un mestiere mai come oggi inviso ai politici, al di qua e ai là dell’Oceano. Ma un mestiere che in realtà è diventato particolarmente prezioso, visto che il suo compito è ridurre la distanza tra la realtà e la sua percezione. Una missione mai così necessaria come oggi.
Cos’è la disintermediazione? E’ il processo che privilegia il contatto diretto tra il cliente e il produttore, senza mediazioni. Vale in politica, dove per parlare agli elettori si ritiene non servano più partiti sindacati e giornali, perché basta un tweet. Vale anche nel recinto della comunicazione, perché la rete, in tutte le sue sfaccettature, ha consentito a un pubblico sempre più vasto di avere diretto accesso alle informazioni, una volta precluse senza la mediazione di giornali e tv. Ciascuno di noi è diventato scrittore, fotografo, editore, comunicatore e lettore. Sicché ora abbiamo molte immagini di auto che esplodono, di naufraghi e fuggiaschi, di torture e impiccagioni, abbiamo gli hurrà di chi vince e il calvario delle prede, abbiamo tanti volti e frammenti di realtà, ma come i frantumi di uno specchio andato in mille pezzi nessuna di queste immagini riesce da sola a darci un’idea del mondo, a dirci che direzione abbia preso e quale sia la meta.
Il giornalismo tradizionale, e vengo al secondo problema, è in affanno perché costa molto e non è più remunerativo come un tempo. Le agenzie di stampa chiudono gli uffici di corrispondenza all’estero, le reti televisive non investono sui viaggi e sulle inchieste. Per i giornali è sempre più difficile tener testa alla rete. Oggi nel mondo ci sono 2,3 miliardi di account attivati sui canali social e 1 miliardo di siti Internet. Sulla sola piattaforma WordPress, ogni 5,7 secondi viene pubblicato un nuovo blog. L’offerta di testi e immagini è imponente, frammentata, in molti casi anonima. Il mercato dell’’industria editoriale tradizionale si riduce, perde copie, perde pubblicità.
C’è poi la terza questione, l’insofferenza della politica nei confronti del giornalismo. Un potere narcisista è sempre più convinto che la politica sia comunicazione e che quest’ultima basti a se stessa. E’ una convinzione dannosa per la qualità della democrazia che, privata di partiti, organi collegiali, processi decisionali trasparenti, ha trasferito il potere di influire sull’agenda pubblica ai professionisti della comunicazione, ai portavoce, agli esperti di marketing.
Penso che occorra accorciare la distanza tra la realtà e la sua percezione. E che questa sia per molti aspetti un’emergenza delle democrazie moderne, messe in pericolo dalla crescente irrilevanza della verità. Il tema è antico, ma è al centro del dibattito pubblico dal 2016, da quando cioè l’Oxford Dictionary scelse la post-verità come parola dell’anno. Costringendoci così a riflettere su una circostanza che era da tempo sotto gli occhi di tutti, e cioè che oggi contano più le emozioni che i fatti oggettivi. Più le suggestioni che i pensieri. Più lo storytelling che le storie. Più la propaganda che l’informazione. E dunque più le bugie che il racconto veritiero dei fatti.
Non è una cosa che riguarda solo la rete, né solo l’informazione, visto che riguarda in primo luogo la politica, il suo linguaggio e la sua etica.
E’ storia antica. Tutte le guerre si combattono anche con l’arma della disinformazione. Il Re Sole, Luigi XIV, stipendiava giornalisti per presidiare il proprio potere. Pisistrato ingannava gli ateniesi presentandosi su un carro dorato, accompagnato da una fanciulla molto alta che si spacciava per la Dea Atena. E all’inizio di questo millennio ci volle una menzogna – quella secondo cui Saddam Hussein possedeva armi di distruzione di massa - per dare un fondamento giuridico e morale all’invasione e alla distruzione dell’Iraq, una scelleratezza di cui milioni di persone stanno ancora pagando le conseguenze.
Le bugie dunque si sono sempre dette. La novità è che nell’era di internet il processo di diffusione della disinformazione dilaga fino a diventare istantaneo e pervasivo. I destinatari della disinformazione si moltiplicano esponenzialmente fino a coincidere con la totalità delle persone collegate in rete. Si moltiplicano anche le fonti possibili, nel senso che chiunque di noi, senza alcuna speciale abilità e senza dover essere un tiranno o un dittatore, può produrre efficace disinformazione, a costo zero.
Paghiamo dunque un prezzo molto alto alla cosiddetta disintermediazione.
Anche in questo caso sono andato alla ricerca di una data-simbolo, e l’ho trovata il 17 dicembre 2006, quando il settimanale «Time», pubblicando in copertina un computer con uno specchio al posto dello schermo, sceglieva come simbolo dell’anno che stava per concludersi «you», tu, cioè «tutte le persone che hanno partecipato all’esplosione della democrazia digitale» usando Internet per diffondere parole, immagini e video. You, cioè noi cittadini del nuovo millennio, che – spiegava la rivista – ci siamo distinti dai nostri predecessori per aver saputo prendere in mano le redini dell’informazione globale, per aver fondato e nutrito la democrazia digitale e per aver fatto tutto questo lavoro completamente gratis, «sostituendoci ai migliori professionisti».
In quel momento, trasferendo la sovranità dai professionisti dell’informazione al popolo della rete e promuovendo Narciso a «Persona dell’anno», «Time» ha inaugurato l’era della post-verità.
In effetti, è stata una rivoluzione. I cittadini hanno avuto accesso a una quantità quasi infinita di informazioni. Ciascuno di noi è diventato scrittore, fotografo, editore, comunicatore, lettore e spettatore. Sicché ora, grazie soprattutto agli smartphone, abbiamo a disposizione tanti frammenti di realtà, ma come i frantumi di uno specchio andato in mille pezzi nessuna di queste immagini riesce da sola a darci un’idea del mondo, a dirci che direzione abbia preso e quale sia la meta.
Il giornalismo tradizionale, quello dei grandi inviati e dei grandi reportage, è in affanno perché costa molto e non è più remunerativo come un tempo. Le agenzie di stampa chiudono gli uffici di corrispondenza all’estero, le reti televisive non investono sui viaggi e sulle inchieste. Il risultato è che mai come oggi abbiamo saputo poco di quel che accade in Medio Oriente o in Cecenia, in Africa o persino nel vicino Kosovo. Oggi nel mondo ci sono 2,3 miliardi di account attivati sui canali social e 1 miliardo di siti Internet. Sulla sola piattaforma WordPress, ogni 5 secondi viene pubblicato un nuovo blog. L’offerta di testi e immagini è imponente, frammentata, in molti casi anonima. Per quanto riguarda le immagini, uno tsunami di pixel si riversa quotidianamente nel web. Duecento milioni di foto caricate ogni giorno su Facebook, per un totale di 6 miliardi al mese, oltre 70 miliardi all’anno. «Un accumulo ingestibile di ricordi a obsolescenza programmata » osserva l’antropologo Marino Niola. È il paradosso della società dell’immagine, che dissipa la memoria in un eccesso di particolari. E, volendo fissare tutto, rischia di non ricordare niente.
Moltitudini di persone stanno essenzialmente all’ascolto dell’eco assordante delle loro stesse voci. Non servono intermediari. Il fondatore del Censis, Giuseppe De Rita, pensa che la disintermediazione, in particolare quella digitale, avrà conseguenze importanti. Pensa che gli strumenti della disintermediazione “si stiano infilando come cunei nel solco di divaricazione scavato tra élite e popolo, prestandosi all’opera di decostruzione delle diverse forme di autorità costituite”.
Forse, come pensa qualcuno, gli intermediari sono stati solo una parentesi, un breve episodio nella storia delle comunicazioni umane. Forse il loro ruolo sociale è tramontato per sempre. E forse un po’ se la sono cercata, facendo spesso male il loro lavoro. Sta di fatto che disintermediazione significa, nell’informazione, il trionfo della spontaneità spesso irresponsabile. Mentre in politica «disintermediazione » significa – in buona sostanza – il trionfo della demagogia e di quella che a Oxford definiscono post-verità.
Proverò a fare qualche esempio, cominciando dal tema cruciale dell’immigrazione.
Nel 2015, ultimo anno per cui sono disponibili i dati Eurostat definitivi, in Italia sono state presentate 1.369 richieste d’asilo per ogni milione di abitanti. In Ungheria sono state 17.700, quindi tredici volte tanto. In Svezia 16 mila, in Austria 10 mila e in Germania 5.500. Hanno avuto più richiedenti asilo dell’Italia, sempre in rapporto alla popolazione, anche Finlandia, Lussemburgo, Malta, Danimarca, Belgio, Bulgaria, Olanda e Cipro. Ricordare questi dati – ignorati nel dibattito pubblico - non significa certo ridimensionare la portata di un problema drammatico e che attualmente vede il nostro paese in prima linea per necessità geopolitiche e anche per una scelta umanitaria di cui andare fieri. Significa misurarlo alla luce e nel confronto con ciò che accade intorno a noi. C’è un impegno – e forse anche un’opportunità, secondo i demografi e i politici più avvertiti – che condividiamo con gli altri. Non siamo soli.
Così come non siamo all’anno zero per quanto riguarda la gestione e le politiche dell’immigrazione. L’anno scorso i «nuovi italiani» – cioè gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza – sono stati 200 mila. Erano stati quasi 180 mila del 2015, 130 mila del 2014 e 100 mila del 2013. Questo vuol dire che ci sono stati più approdi alla cittadinanza che sbarchi sulle coste. Gli immigrati ormai si dividono tra chi si è integrato e chi vaga alla ricerca di un luogo in cui fermarsi a vivere. Ci occupiamo molto – e giustamente – del secondo fenomeno, ma è il primo che sta mutando il profilo e la natura della nostra società. La politica e l’informazione - che per troppi aspetti coincidono - non si accorgono che l’Italia cambia pelle, mutazione che invece si vede bene nelle scuole, nelle parrocchie e nei campetti dove i ragazzi giocano a calcio. Le notizie sulla nuova Italia, quella del presente e soprattutto quella futuro, ce le portano dunque le mamme, gli insegnanti, i preti, gli allenatori delle squadre giovanili di calcio o di atletica leggera. Ce le porta anche il presidente dell’Inps professor Boeri, con i suoi numeri sul contributo dell’immigrazione alla tenuta del sistema della previdenza sociale. Ma non bastano questi dati di fatto a suggerire un approccio alla questione dell’immigrazione più equilibrato, meno emotivo e in definitiva più utile.
La distanza tra la realtà è la sua percezione diventa abissale quando si parla di Europa. L’immagine che ci viene proposta (che soprattutto viene proposta ai nostri ragazzi) è quella dell’Europa ottusa dei burocrati e quella avida dei banchieri, l’Europa dello zero virgola, l’Europa che impone la misura delle vongole, l’Europa che ci strozza, l’Europa che ci lascia soli. Toni e contenuti populistici che stanno permeando anche partiti tradizionalmente europeisti e che ormai sono ricorrenti nel linguaggio di leader che per la storia e le loro responsabilità dovrebbero esserne immuni.
Voci sempre più flebili ricordano che l’Unione europea – che quando agisce come un’unica entità, è la più grande economia del mondo – garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, in un mercato unico in cui viene tutelata la concorrenza. Ma soprattutto presidia valori come la libertà, la democrazia, i diritti umani e la pace, una pace robusta non perché imposta ma perché nasce dalla volontà di cooperazione tra diversi. L’Europa è la bandiera che stringe tra le mani chi fugge dalle guerre, è la culla dello sviluppo sostenibile, è la metà della spesa sociale erogata al mondo.
E, se davvero ce lo chiedesse l’Europa di avere ospedali efficienti, energie rinnovabili, processi veloci e debiti sopportabili, perché dovremmo lamentarcene? E infatti non ci lamentiamo, se non in televisione e in campagna elettorale. Perché con la Lituania e la Lettonia l’Italia è l’unico paese europeo che negli ultimi due anni non ha mai votato contro una decisione del Consiglio dell’Unione. Secondo i dati riferiti dal Sole 24 Ore, nelle sedute del Consiglio l’Italia ha votato sì 148 volte su 148 scrutini. . Quel «frenetico immobilismo» dell’Europa di cui ha parlato alla Camera un ex presidente del Consiglio citando Jürgen Habermas, ha potuto dunque giovarsi di un decisivo contributo italiano.
Occorre ridurre la distanza tra la realtà e la sua rappresentazione nell’universo digitale. Spiegare ad esempio che la web tax non è una tassa su internet, ma sui profitti di chi utilizza internet per impossessarsi della nostra identità e rivenderla al miglior offerente.
Spiegare che Internet non è affatto il regno della libertà, e non è affatto vero che Internet non abbia padroni. Il web ha padroni ricchissimi e potenti che hanno trasformato un progetto costruito da una intelligenza collettiva e generosa in uno strumento al servizio degli interessi economici e politici di un ristrettissimo numero di imprese e istituzioni. I padroni di Internet sono gli «Over the Top», ovvero le società che smistano il traffico sulla rete ricavandone grandi profitti.
L’eccezionale capacità dei giganti del web di catturare investimenti pubblicitari è legata ai dati che possiedono, che permettono loro di conoscere a fondo i loro utenti e di proporre categorie e profili dettagliati agli inserzionisti per campagne sempre più mirate.
E’ evidente l’asimmetria: noi forniamo i dati (a cominciare dalla nostra identità) e loro li sfruttano per fare quattrini. Negli Stati Uniti raccogliere informazioni è più facile che in Italia perché lì la privacy è meno protetta: età, sesso, etnia, religione, istruzione, reddito, case di proprietà, statuto socioeconomico, debiti, fattori geografici, eventuali crimini, stato di salute, l’auto che guidate, i prodotti che comprate, i giornali che leggete, i club a cui appartenete. Tutto è schedato, tutto è utilizzabile con e spesso senza il nostro consenso. È un meccanismo micidiale. Facebook e i suoi proprietari dispongono di una rete che descrive le connessioni tra quasi due miliardi di persone e che consente di conoscerne le preferenze, le ansie, le speranze. L’Università di Cambridge, in collaborazione con Microsoft, ha studiato i profili di 58 mila utenti americani di Facebook e analizzato i loro «mi piace». Alla fine i ricercatori sono riusciti a individuare le preferenze politiche degli intervistati nell’85% dei casi. Nel 95% hanno capito – senza guardare le foto – se si trovavano di fronte a un bianco o a un afroamericano. E 88 volte su 100 i «like» gli hanno detto se l’utente di Facebook era gay o no. La domanda è cosa accadrebbe se una conoscenza così capillare delle attività e delle abitudini dei singoli utenti fosse usata non solo per finalità commerciali ma anche per scopi politici (come pare sia di recente avvenuto nel caso di Cambridge Analytics) o di controllo sociale, o addirittura per scopi illeciti. Sarà anche per questo che Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook valgono in Borsa oltre 3 mila miliardi di dollari, un dato superiore al pIl della Francia.
Occorre darsi delle regole all’altezza delle nuove sfide tecnologiche. La capacità di calcolo, la disponibilità di banda trasmissiva, la riduzione del consumo energetico per unità di calcolo e la riduzione del costo di sensori e attuatori grazie alla diffusione degli smartphone hanno subìto una straordinaria accelerazione. Questo ha reso disponibile tecnologia estremamente sofisticata a costi marginali, creando grandi opportunità ma anche grandissimi rischi sotto il profilo della qualità dei soggetti che accedono e utilizzano i dati, delle concentrazioni di mercato, dell’accesso
fraudolento a dati sensibili, ma anche dell’influenza politica e sociale che lo sviluppo delle piattaforme di intelligenza artificiale che hanno accesso a dati personali sensibili può determinare.
Mentre fino a poco tempo fa il tema della privacy era prevalentemente un tema di protezione dei dati personali, oggi è diventato un tema molto più complesso di protezione dell’individuo da condizionamenti indesiderati.
L’obiettivo principale di chi gestisce il traffico on line è quello di conquistare l’attenzione e l’interesse di quelli che per capirci chiamerò consumatori, ben sapendo che sono prima di tutto persone, poi cittadini, poi utenti.
L’attenzione dei consumatori è il bene cruciale (e carente) del mercato. L’attenzione ha una sua economia, se ne occupano specialisti di varie discipline. Era economista, psicologo e informatico Herbert Simon, premio Nobel, che nel 1971 scriveva: «L’informazione consuma attenzione. Quindi l’abbondanza di informazione genera una povertà di attenzione e induce il bisogno di allocare quell’attenzione efficientemente tra le molte fonti di informazione che la possono consumare».
Molta dell’attività di Internet, da parte di chi è interessato al profitto e ad altri beni, è progettata per creare maggiore attenzione, anche soltanto per un momento.
In un periodo d’inflazione di informazioni, l’attenzione è diventata una merce molto rara e molto costosa. Scarsa come il tempo delle persone. Importante come il denaro. Per catturare l’attenzione non serve approfondire, verificare, filtrare, sistematizzare. Spesso basta proporre un pensiero semplificato, non importa se labile o bugiardo. Esattamente ciò che noi non possiamo permetterci.
C’è anche la strategia opposta, quella della disattenzione, messa a fuoco da Luca De Biase, direttore di «Nova», l’inserto del «Sole 24 Ore» dedicato all’innovazione. Poiché i comportamenti sono dettati molto più spesso dall’intuizione che dal ragionamento e poiché il ragionamento richiede molta più attenzione dell’intuizione, ecco che la disattenzione può essere una condizione ideale per favorire certi comportamenti consumisti. La disattenzione funziona quando l’idea – il messaggio – viene ripetuta in maniera molto insistente attraverso mezzi differenti e in modo coordinato, e tende a diventare, per molte persone, appunto, «la prima idea che viene in mente».
Scrive De Biase che l’ecosistema della conoscenza vive in modo sano se coltiva l’infodiversità, se i messaggi deboli e non urlati non sono continuamente cancellati dalla violenza dei predatori che puntano tutto sulla strategia della disattenzione.
Se gli esperti, gli scienziati, gli artisti non sono costretti a trasformarsi in comunicatori con l’altoparlante sempre acceso solo per farsi notare.
Se l’ecosistema trova il giusto spazio per tutti, senza selezionare a priori soltanto quelli che sanno occupare il palcoscenico.
Se tra i gruppi sociali che generano informazione sussiste una relazione di simbiosi, non solo di caccia e di lotta per la sopravvivenza.
Ed è esattamente questa la strada che noi vi proporremo di percorrere.
Il problema della scarsità della «risorsa attenzione» ha avuto un importante impatto anche nel settore della pubblicità.
Alberto Contri, copywriter, direttore creativo, grande esperto di comunicazione, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso e autore di McLuhan non abita più qui?, sostiene che viviamo nell’era della «costante attenzione parziale». Espressione che definisce la situazione complicata in cui si trovano imprese e comunicatori di fronte al radicale mutamento antropologico che si sta verificando nei nuovi consumatori. Basta osservare le persone in attesa alla fermata di un autobus; difficile trovarne una che non tenga gli occhi fissi sul suo smartphone, intenta a inviare o ricevere messaggi, chattare su WhatsApp, Twitter, Facebook, guardando siti sulla rete.
Un comportamento che diventa patologico quando interferisce con ogni altra attività di relazione, che si stia a tavola, che si stia parlando con altri, che si stia partecipando a una riunione o a una lezione, che si stia fruendo di altri media. Come si può riuscire a superare la barriera del rumore di fondo che circonda e assedia i nativi digitali? «Esattamente come si fa per attirare l’attenzione dei bambini» risponde Contri. «Raccontando loro una storia che li interessi o li diverta, così da far passare in secondo piano qualsiasi altro disturbo o interesse divergente».
Nasce così lo storytelling, che funziona per vendere i prodotti, e chissà che non possa funzionare anche per far crescere le biblioteche.
La scarsità della risorsa attenzione ha naturalmente a che fare con l’overdose di informazione.
Il quotidiano francese «Libération» ha messo in rete il filmato di una straordinaria intervista a Jorge Luis Borges realizzata nel 1969 nel suo studio alla Biblioteca nazionale argentina, di cui era direttore.
«Adesso c’è troppa informazione», diceva Borges, «si stava meglio nel Medioevo. C’erano pochi libri, ma tutti li leggevano».
Oggi il problema si è aggravato se è vero che – secondo i dati riferiti da Eric Schmidt, presidente del consiglio d’amministrazione di Google – ogni due giorni generiamo una quantità di informazioni pari a quella creata dall’inizio della civiltà a oggi.
La situazione potrebbe precipitare quando la produzione dell’informazione sarà nella piena ed esclusiva disponibilità dei bot, software che creano profili-clone su Facebook o Twitter,
i quali a loro volta generano contenuti, messaggi e nuovi cloni, in fulminea e infinita successione, creando quel «diluvio informazionale» che finirà per travolgerci. Se non costruiamo degli argini. Nell’agosto 2012, su «l’Espresso», Umberto Eco scriveva che esiste una «censura per eccesso di rumore», come sanno spie o criminali dei film gialli che, se devono confidarsi qualcosa, mettono la radio al massimo volume.
La quantità di messaggi che passa attraverso la rete può avere – secondo Eco – un effetto analogo.
Un’intera generazione rischia di crescere senza selezionare quello che legge.
E dunque, in conclusione: troppa informazione, nessuna informazione.
La questione ha ovviamente a che fare con lo sviluppo della tecnologia.
Dieci anni fa, Nicholas Carr scatenò un dibattito che ancora prosegue: «Mi manca il mio vecchio cervello, Google ci rende stupidi» scrisse lo scrittore americano in un ormai celebre articolo.
Ne ricavò anche un libro, Internet ci rende stupidi?.
Oggi secondo molti osservatori – psicologi, antropologi, sociologi – l’unica novità sembra la scomparsa del punto interrogativo.
Era l’epoca dei laptop e delle email. Ora giriamo con lo smartphone e viviamo sui social network. Il problema, ha detto Carr recentemente, è diventato più evidente e più grave. Il nostro cervello è malleabile. Se viene bombardato da distrazioni e interruzioni continue, si adatta di conseguenza.
Non siamo in grado di finire una cena senza controllare il cellulare, siamo sempre più in balìa del flusso di informazioni, più distratti che mai. Gli effetti? L’attenzione diventa frammentaria, siamo meno capaci di riflettere e di pensare in profondità. Anche la memoria ne risente. Non è l’informazione in sé a instupidirci, ma l’intensità con cui siamo gettati nel flusso.
L’intelligenza non è solo trovare informazioni rapidamente, ma la capacità di attribuirvi un senso: il pensiero critico oggi è a rischio. Se come individui diventiamo più superficiali, a livello collettivo – concludeva Carr - gli esiti non saranno granché.
La politica assiste passiva all’affermarsi di questo nuovo immenso potere che si sottrae a ogni controllo. Ed è vistosa la subalternità, anche culturale, dei media tradizionali, e in particolare della tv, nei confronti di un soggetto – il web – che si propone di spazzarli via.
Tutto ciò che accade in rete sembra ai media straordinariamente importante. Il popolo della rete, la protesta della rete, il dibattito in rete. Com’è noto, le bacheche dei social network raccolgono, accanto ad alcune cose interessanti, molta spazzatura: ingiurie, diffamazioni, minacce, oscenità. Per molti aspetti, quei contenuti sono gli stessi che un tempo si trovavano sulle pareti dei bagni pubblici, quando quei luoghi ancora esistevano, prima di scomparire insieme al servizio di leva obbligatorio. Ma non ricordo che allora i giornali considerassero rilevante l’opinione di quel particolare popolo, né che i suoi graffiti fossero consultati e recensiti come termometro degli umori correnti.
Ripristinare la verità dei fatti sta diventando un’urgenza democratica.
E’ urgente spiegare che uno vale uno non è una regola che si possa applicare alla scienza e dunque alla medicina. Ma anche che “uno vale uno” in politica ha senso se non c’è uno che vale tutti. Occorre dire che la rete non è nemica della democrazia rappresentativa ma la può, al contrario, arricchire. Che in Italia non ci sono mai stati presidenti del consiglio e governi eletti dal popolo, perché li elegge il parlamento. Che dopo America first non può venire “Italia first” o “Emilia first” perché non esiste un gioco dove tutti vincono e perdono sempre gli altri. Che se oggi contano più le emozioni che i fatti, siamo di fronte a un mondo capovolto che dovremmo raddrizzare. Che la distanza tra la realtà e la sua rappresentazione si può ridurre.
Come? In vari modi. Il «New York Times» avvicina i lettori con lo slogan «La verità è difficile da trovare. Ma è più facile cercarla con mille giornalisti». L’investimento sull’informazione di qualità è insomma una via d’uscita, ovviamente costosa, che però può rivelarsi un affare. A patto di non essere succubi della rete, ma, al contrario, di saperla utilizzare per migliorare il prodotto e ampliare il proprio target. Esemplare il caso del «Washington Post», che nell’estate del 2013, quando perdeva 54 milioni di dollari l’anno, fu acquistato da Jeff Besos, fondatore e Ceo di Amazon. In seguito Bezos ha introdotto numerose innovazioni di tipo tecnologico e di contenuto editoriale, aumentando per esempio gli articoli pensati per attirare interesse sui social network. Evitando dunque che sugli smartphone dei teenager arrivasse solo la spazzatura prodotta dai siti di fakes (che in Italia è il cruccio di ogni buon padre di famiglia). Ha ingaggiato programmatori, web analyst, big data analyst, web designer e video editor. Ha reso ultraveloce la versione mobile, ha cercato e trovato nuovi pubblici su diverse piattaforme distributive, ha aumentato i contatti, gli accessi a
pagamento, e grazie a entrambi ha aumentato la pubblicità. Ma soprattutto ha assunto decine di giornalisti che sono andati a rafforzare il team delle breaking news e quello delle inchieste, il più apprezzato dai lettori Ora il «Washington Post» è il secondo quotidiano degli Stati Uniti per numero di lettori. E soprattutto macina utili. Un analogo percorso di transizione al digitale con importanti investimenti sul prodotto è stato intrapreso da Axel Springer, il numero uno dell’editoria tedesca («Bild Zeitung», «Die Welt», «Business Insider »). Anche in questo caso gli investimenti hanno pagato. Dunque: conquistare la Rete e non subirla, investendo sul giornalismo e le tecnologie. Solo così si potrà evitare che le strade dell’informazione di massa e quelle dell’informazione di alta gamma si separino, come è successo all’abbigliamento, al cibo e ad altri beni di prima necessità. E che la seconda costi molto più della prima, e sia dunque riservata a un pubblico selezionato, o che comunque se la possa permettere.
Ma ci sono altre risposte, non di mercato, alla sfida dell’eccesso di informazione e della post-verità. Il giurista Cass R. Sunstein (Republic.com) giudicando inammissibile l’idea che la libertà di parola fosse da considerarsi un «assoluto» e ritenendo che la difesa della democrazia dovesse avere la precedenza, spiegò che occorrevano forme di autoregolamentazione volontaria. Un accordo tra produttori per impedire che i notiziari fossero una continuazione delle fiction, che prevalesse il sensazionalismo, che le opinioni fossero censurate. Un’ulteriore proposta prevede che i gestori della rete, e in particolare i social, rinuncino alla loro pretesa di neutralità e si assumano la respnsabilità di ciò che pubblicano, rimuovendo i contenuti tossici. Come accade ai media tradizionali.
Come sappiamo, per l’apparato giuridico convenzionale il web è zona franca. Sembrano non valere sul web – nel senso che non vengono in genere fatti rispettare – l’art. 494 del codice penale che vieta la sostituzione di persona o l’attribuirsi un falso nome, l’art. 656 che vieta la diffusione di notizie false o tendenziose che turbino l’ordine pubblico, l’art. 612 che vieta la minaccia e il 612 bis che vieta lo stalking, l’art. 595 che vieta la diffamazione, l’art. 660 che vieta le molestie, per non dire delle norme che fino a pochi mesi, sanzionavano l’ingiuria, solo di recente uscita dal perimetro del processo penale. E di quelle a tutela della privacy.
Un’ulteriore proposta per arginare l’invadenza delle fabbriche di fake news e per intaccare il loro business è rivolta ai grandi inserzionisti – multinazionali come American Express, Vodafone e simili. A loro si chiede di ritirare la pubblicità da quei siti che devono la loro popolarità e dunque i numerosi click alla sistematica falsificazione dei fatti. Senza i soldi della pubblicità distribuiti dagli algoritmi che misurano il traffico e se ne infischiano dei contenuti, quattro quinti di questi siti chiuderebbero bottega.
C’è poi la strada dell’autodisciplina e della buona educazione di chi produce le notizie e di chi le consuma. I giornalisti dovrebbero ricordarsi che lavorano in un’epoca storica in cui «sembra che il pubblico stia litigando con i fatti», e dovrebbero evitare di trasformarsi nella cassa di risonanza delle false notizie, ad esempio usando i siti di fact checking o verificando e confrontando le fonti. Dovremmo insomma attenerci alle regole d’oro del nostro mestiere: il controllo dei fatti, che sarebbe ciò per cui ci pagano, e l’onestà nel riferirli.
L’onestà è perfettamente compatibile con le passioni e con le idee a cui ciascuno di noi vivendo si affeziona. L’importante è non spacciare per fatti le passioni e per verità le idee.
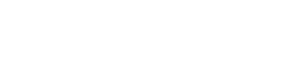



 amministrazione
amministrazione