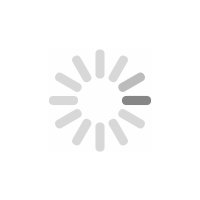Una copia ingiallita del Corriere dei Piccoli, anni Quaranta. La sfoglia una professoressa di scuola media alla ricerca di storie risorgimentali che possano incuriosire i suoi studenti. Si ricorda che, da bambina, l’amato settimanale aveva una rubrica intitolata “Vite di donne all’ombra dei grandi”. Erano soprattutto ritratti di madri: c’era quella di Garibaldi, quella di Napoleone. Ma anche quella dei fratelli Emilio ed Attilio Bandiera. Di lei, Anna Maria Marsich, veniva narrato solo un episodio: quello che la vede raggiungere a Corfù i figli esuli e ribelli per implorarli di ritornare a Venezia insieme a lei, per pentirsi dei loro piani rivoluzionari e ricevere il promesso perdono imperiale, tornando a servire fedelmente sotto l’aquila austriaca della Imperial Regia Veneta Marina e a mantenere loro, ufficiali e baroni, tutti i privilegi della propria casta. Ma il pianto della madre non riuscirà ad infrangere la fede nell’“ora e sempre” mazziniano del 38enne Emilio, alfiere di fregata e del 29enne Attilio, alfiere di vascello. Si metteranno a capo della temeraria spedizione per sollevare il popolo del Regno delle due Sicilie, 12 anni prima di Garibaldi. Ma non in mille, in 19. E le patriottiche parole di Attilio Bandiera – “è fede nostra giovare l’Italica libertà meglio morti che vivi” - si avvereranno davanti al plotone di esecuzione, il 25 luglio 1848. Quello che emerge, così, è un drammatico conflitto privato sullo sfondo di quello epocale dell’Italia risorgimentale. A rispecchiare il tormento di tanti italiani dell’epoca, divisi tra reazionari e rivoluzionari. In Thea Magliozzi, la prof di Gaeta che ricorda l’antica lettura sul Corriere dei Piccoli, il pensiero di quella madre, fedele suddita dell’impero austro-ungarico e nobildonna, che la storia ritrova nel 1867, impassibile e vestita di nero, vedere solennemente tumulate i resti dei figli nel Pantheon dei Dogi a Venezia, la Basilica dei S.S. Giovanni e Paolo, solleva crescenti interrogativi. Che la porteranno a pubblicare nel 2006 - due anni prima della morte, avvenuta a 75 anni - l’unico libro dedicato a questa figura, rimasta fino ad allora misconosciuta, “La Baronessa. La madre dei fratelli Bandiera”. La genesi del libro è affascinante perché, improvvisamente, durante il lavoro di stesura, l’autrice scoprirà addirittura di essere una lontana parentela della sua eroina. Scoprendo anche una pagina storica ignorata dell’avventura dei fratelli Bandiera: il viaggio in incognito che la baronessa fece a Cosenza, dove i figli erano stati arrestati dopo il fallito moto in Calabria, per cercare di salvarli dalla condanna a morte. “La scoperta del viaggio segreto della baronessa fu del tutto casuale: merito di mia madre che ascoltava volentieri qualche pagina man mano che procedevo nel mio lavoro. Fu quando le lessi una breve lettera di Attilio indirizzata allo zio Raffaele Del Giudice, un ufficiale borbonico. A quel nome lei m’interruppe esclamando: ‘Era un amico dei bisnonni Vendittis! Sua moglie si chiamava Caterina. Abitavano a Napoli e venivano spesso a Gaeta. Una volta venne ospite anche una sorella di Caterina che viveva a Venezia. Poveretta, lei aveva delle grosse preoccupazioni per i figli…’”. Era quindi lei quella “poveretta”, la baronessa Marsich, che aveva fatto tappa a Napoli per ottenere, inutilmente, la grazia dalla regina Marina Teresa, moglie di Ferdinando II di Borbone.
Quella improvvisa scoperta di parentela spiega ancora meglio il perché dell’empatia che da subito la professoressa appassionata di storia aveva sentito per la baronessa: “La sentivo accanto a me, quasi la sentivo vivere in me, combattuta fra l’ira, l’onta e la speranza in un pentimento di quei figli disertori ed esuli”. E infatti quando inizia a scrivere il suo libro parte dal racconto del disperato viaggio della nobildonna veneziana verso l’isola greca di Corfù, decisa a riportare indietro i figli suoi e del conte Francesco, ammiraglio comandante della flotta austriaca nel Mediterraneo, celebre per avere catturato un bastimento carico di profughi. L’autrice la immagina, tormentata, di fronte ai due ardenti veneziani, abbronzati sotto il sole greco, gli sguardi ardenti, nell’immensità azzurra del mare, puntati in direzione delle coste italiane, da dove gli era giunta la notizia del moto calabrese di marzo e poi contraddittorie informazioni sulla sua sconfitta. È vero che ci sono stati degli arresti e che la Sicilia ancora è ferma ma su Cosenza ora sventola la bandiera repubblicana, nelle foreste della Sila si nascondano numerose bande degli insorti, anche la Puglia si va organizzando. Mancano solo delle figure decise con animo fermo a guidare l’insurrezione. E invece già stanno in carcere i condannati a morte, a Cosenza il tricolore ha sventolato poche ore, nelle foreste girano in forze solo i banditi. “Il grido di guerra dei nostri fratelli - scriverà a maggio Attilio a Mazzini - mi romba continuamente all'orecchio; ed io ho già preso tutte le disposizioni per slanciarmi quanto prima a combattere con essi e perire”. Mazzini da Londra cerca inutilmente di dissuaderlo, Nicola Fabrizi da Malta lo mette apertamente in guardia dal sacrificarsi per una “irragionevole disperazione”. Ma decideranno di “correre la sorte” come scriverà Emilio a Mazzini a giugno, poco prima della partenza, “poiché la vita ci fu data per utilmente e nobilmente impiegarla, e la causa per la quale avremo combattuto e saremo morti è la più pura la più santa che mai abbia scaldato i petti degli uomini: essa è quella della Libertà, dell'Eguaglianza, dell’Umanità, della Indipendenza e dell'Unità Italiana”.
La madre non riesce, nell’incontro a Corfù, ancora a capire che i suoi figli hanno incarnato nel senso più nobile la rettitudine morale ed il coraggio della sua famiglia che vanta ben 11 appartenenti alla Imperial Regia Veneta Marina. Allora, oppressa dall’angoscia, li vede solo come degli scapestrati che hanno rischiato di farsi ammazzare per convincere gli altri ufficiali austriaci ad aderire alla società segreta Esperia che loro avevano fondato nel 1840 e perché sognavano una Italia unita in una repubblica retta da forti principi, in cui “la libertà non può mai regnare dove non sienvi severi costumi”. Tutta a causa - in quella che poteva essere la visione di quella madre disperata - di quel Pietro Maroncelli, carbonaro napoletano che, quando Attilio aveva solo 10 anni, aveva sfiorato il patibolo in piazza San Marco, insieme al compagno Silvio Pellico. E che poi Attilio, a 25 anni, ormai energico ufficiale di una corvetta imperiale, aveva ritrovato, esule a New York. Restando folgorato dalla tempra e dagli ideali di quell’uomo sopravvissuto ad otto anni di carcere nello Spielberg. E quelle idee avevano finito per contagiare anche il più giovane Emilio. Poi l’incontro a Malta, nel 1842, con l’esule modenese Nicola Fabrizi e braccio armato della Giovine Italia, che aveva spinto i due fratelli a partecipare al folle progetto di impadronirsi di alcune navi da guerra austriache: Attilio deciso a guidare l’ammutinamento della fregata “Bellona”, di stanza a Smirne. Il tradimento proprio di un affiliato dell’Esperia, Tito Vespasiano Micciarelli, nel febbraio 1848, aveva fatto però saltare i loro piani. I fratelli, ad un passo dall’arresto, avevano riparato per vie diverse in Grecia, dove poi si erano ritrovati in aprile, a Corfù. E dove la madre (peraltro nata in questa isola, da una famiglia bosniaca), inviata come mediatrice dall’arciduca Rainieri in persona, li aveva subito raggiunti per farli rinsavire. Di quel drammatico incontro Thea Magliozzi può farsi una idea leggendo una lettera di Emilio a Mazzini: “Invano io le dico che il dovere mi comanda di restar qui; che la patria mi è desiderata, ma che, allorquando mi muoverò per rivederla, non sarà per andarmene a vivere di ignominiosa vita, ma a morire di gloriosa morte; che il salvacondotto mio in Italia sta ormai sulla punta della mia spada; che nessuna affezione mi potrà strappare dall'insegna che ho abbracciato, e che l'insegna d'un re si può abbandonare, quella della patria mai. Mia madre, agitata, accecata dalla passione non m'intende, mi chiama un empio, uno snaturato, un assassino; e le sue lagrime mi straziano il cuore. I suoi rimproveri, quantunque non meritati, sono come punte di un pugnale; ma la desolazione non mi toglie il senno; io so che quelle lacrime e quello sdegno spettano ai tiranni; però, se prima non ero animato che dal solo amor di patria, ora è potente l'odio che provo contro i despoti usurpatori, che per l'infame ambizione di regnare sull'altrui patrie condannano le famiglie a siffatti orrori”.
Qui si fermerebbe la storia della baronessa Marsich se Thea Magliozzi non avesse sentito l’esigenza di fare uscire la sua vita dal cono d’ombra della leggenda dei figli. Quando inizia a raccogliere documenti su di lei non ne sa neanche il nome di battesimo, per conoscerne i natali si rivolge al Museo Correr di Venezia. Passa giorni interi nella biblioteca nazionale a Roma trovando tanto sui figli quanto poco sulla madre, fa allora un certosino lavoro di ricerca negli elenchi telefonici per rintracciare gli eredi, Maria Grazia e Sergio Marsich (quest’ultimo docente emerito di Ingegneria navale all’Università di Genova). Cerca di riannodare i sottili fili di una esistenza attraverso una serie di lettere. Ricostruisce così l’“enorme conflitto” che attanaglia Anna Maria Marsich, “perché lei ha vissuto le vicissitudini, le speranze, le delusioni, i lutti che ci sono stati, pensiamo a Daniele Manin, alla Repubblica romana, la fame, i bombardamenti, la carestia. Lei sa che queste ribellioni sono destinate a finire nel nulla. O nell'esilio”.
E, per la prima volta, apre una pagina inedita nella storia della tragica impresa dei figli, scia di sangue dello sconfitto moto calabrese del marzo 1844. Quello della madre che, prima in pena per l’editto di comparizione austriaco, poi appresa della loro cattura in Calabria, corre a Cosenza solo in tempo per vederli condotti alla fucilazione. Non ci sono, in questa storia, il racconto delle gesta eroiche dei figli: lo sbarco, il 17 giugno 1844, vicino Crotone, dopo 4 giorni di mare su un trabiccolo, il suono dei dialetti - soprattutto emiliani e romagnoli - del gruppetto di 19 uomini che toccando la terra italiana la bacia e ascolta Emilio esclamare: “Tu ci hai dato la vita e noi la spenderemo per te”; il Nivaro, il brigante calabrese che guida il drappello alla volta di Cosenza, l’avventuriere corso unito al gruppo che, visto che non c’è nessuna sollevazione popolare ad accoglierli ma solo contadini che riferivano di arresti e fucilazioni, decide di andare a fare la spia alla polizia borbonica; la caccia delle guardie tra i boschi della Sila; il primo scontro a fuoco, di notte, a Pietralonga; la fuga disperata dei patrioti verso San Giovanni in Fiore, accerchiati da gruppi armati, anche di semplici cittadini, che li credono solo pericolosi briganti; l’agguato, all’alba del 19 giugno, all'inizio della pineta silana, sotto il fuoco di duecento guardie. Un quarto d’ora d’inferno: poi i fratelli Bandiera in manette, Emilio con la spalla slogata per aver cercato di saltare un fosso, due compagni uccisi. La gente di San Giovanni in Fiore che li malmena ed insulta. “Dedizione” che il re si affretterà a ringraziare nei giorni successivi al comune silano con medaglie, privilegi fiscali e pensioni.
Nella storia di Anna Maria Marsich ci sono invece le lettere che lei lesse sgomenta. Quelle che i figli, prima di partire da Corfù per la Calabria, avevano inviato a suo marito, per invocare l’estremo perdono del padre, che li aveva rinnegati. “Voi non siete capace di odiare nessuno e non vorrete odiare due figli che, se hanno errato, lo fecero per troppo vibrato sentire” le parole di Emilio. “Alla famiglia preferimmo l'umanità e la patria, e noi credemmo d'aver fatto il nostro dovere”, “mi ridoni il di Lei affetto in questo supremo momento” scrive Attilio.
E ci sono anche le lettere scritte da Attilio, prima della condanna a morte, a Ferdinando II di Borbone che, considerate sinora dei falsi da chi le ha interpretate come tentativi dell’ufficiale di sfuggire alla fucilazione, dimostrano invece che i due fratelli erano pronti ad accettare l’Unità italiana anche sotto la bandiera borbonica.
E c’è il trafelato viaggio della baronessa verso Cosenza che, dopo la richiesta di grazia terrena alla regina di Napoli, inizia un pellegrinaggio alla volta di Cosenza, che la vede scendere di carrozza ad ogni chiesa per chiedere la grazia divina. Il suo desiderio di rivedere i figli si avvererà solo per vederli condotti davanti al plotone di esecuzione, il 25 luglio 1844. Insieme ad altri sette compagni, incappucciati e a piedi nudi, camminano verso il luogo del loro supplizio. Prima di farsi mettere la benda nera sugli occhi Emilio Bandiera aveva detto: “Son pago di morire in terra italiana e per moschetto italiano invece di tedesco”. Poi quei seicento passi scalzi e barcollanti, lungo la rapida discesa che ne feriva i piedi, che i condannati a morte, ognuno con accanto un frate, compiono in una interminabile mezz’ora. Cantando il coro della “Caritea” di Mercadante: “Chi per la patria muor, vissuto è assai”. Un canto che commosse molti, persino i soldati. Turbati puntarono i moschetti e mirarono male contro i condannati che gridavano: “Fratelli, tirateci al petto e poi gridate: Viva l'Italia”. E purtroppo dovettero sparare una seconda scarica per finire gli agonizzanti.
Così narra Thea Magliozzi nel suo libro la madre che vede andare i figli a morire: “Contava sulla sua forza d’animo che l’aveva sempre sorretta nelle avversità. Ma ciò che vide la sconvolse. Un braccio avvinghiato all’altro, le unghie conficcate nella pelle, trattenne a stento un grido: non erano i suoi figli, non erano i loro compagni quelli che uscirono dalla conforteria ognuno con due soldati accanto e un sacerdote! Lunghi camicioni e veli neri spioventi dal capo, sobbalzavano a piedi nudi sulle asperità del suolo scendendo dal colle Triglio verso il Vallone di Rovito, presso il greto del Crati. ‘Come, come hanno potuto inventare una simile crudeltà? Non basta togliere loro la vita? Perché ridurli fantocci senza volto e senza dignità?’. Avrebbe voluto uscire di corsa, seguirli e strappare quei veli dai loro visi: che vedano ancora la luce e il cielo che Dio ha creati per tutti! Perché privarli anzitempo? L’avrebbe fatto, sì, certo! Ma avrebbe turbato il raccoglimento di quei giovani che s’erano preparati alla morte con la certezza della vita futura e la fiducia che dal loro sangue sarebbe nata la riscossa d’Italia, come le aveva detto don Beniamino per confortarla. Lentamente il corteo sparì alla vista e la strada rimase deserta. Ella udiva ancora il tramestio dei soldati in lontananza quando d’un tratto si levò l’armonia di un coro mesto, travolgente: il motivo di un’opera nota. Cantavano. Li avevano mascherati da fantocci, neri, scalzi e ora si rivelavano uomini, eroi”.
La forza morale dei figli, che tanto devono proprio al suo insegnamento, dimostra così alla baronessa quanto il loro sogno ideale fosse quello di una intera generazione. Aveva lasciato Venezia insorta, nel marzo ’48, con la Repubblica di San Marco guidata da Repubblica di San Marco Daniele Manin e Niccolò Tommaseo e nei tanti ragazzi, anche volontari giunti da ogni parte d’Italia, che oppongono la loro eroica resistenza agli austriaci, sostenuti da Guglelmo Pepe, ritrova tutto l’ardore dei suoi figli. Anche quando l’artiglieria di Radetzky ed il colera li piegherà del tutto, nell’agosto ’49, sa che il sogno è solo rinviato. Mazzini scrisse in memoria dei fratelli Bandiera delle parole che la madre ora poteva finalmente capire: “Il martirio per una Idea è la più alta formula che l'Io umano possa raggiungere ad esprimere la propria missione”, “i sacrificati a Cosenza hanno insegnato a noi tutti che l'uomo deve vivere e morire per le proprie credenze: hanno provato al mondo che gl'Italiani sanno morire: hanno convalidato per tutta l’Europa l’opinione che una Italia sarà .... Confortatevi, o giovani, la nostra causa è destinata al trionfo….. Voi potete uccidere pochi uomini, ma non l'Idea. L'Idea è immortale. L'Idea ingigantisce fra la tempesta e splende ad ogni colpo, come il diamante, di nuova luce”.
(Marina Greco)
(© 9Colonne - citare la fonte)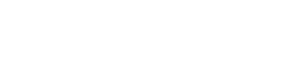





 amministrazione
amministrazione