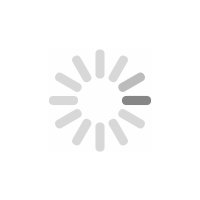“Robert - chiede il dottor Teller a J. Robert Oppenheimer - se i giapponesi sapessero cosa stiamo per fare, credi che si arrenderebbero?” “Non lo so”.
Non lo so o non importa?
Sembra racchiudersi in questo dialogo lo snodo morale fondamentale dell’ultimo mastodontico film di Christopher Nolan. Approdato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 23 agosto, “Oppenheimer” è un film dai pochi difetti che con estrema raffinatezza estetica racconta in modo squisitamente personale la parte forse più nota della storia del Secolo breve.
Proprio la natura personale della narrazione rivela il vero intento dell’autore per il quale la storia come res gestae fa solo da contorno all’intima indagine che investe i suoi protagonisti; al di là dell’organizzazione militare e delle enormi implicazione politiche che gli diedero vita e lo diressero, il presupposto del Progetto Manhattan furono proprio i suoi protagonisti: scienziati e studiosi della più alta levatura selezionati e riuniti allo scopo di consegnare loro il destino ultimo del conflitto mondiale. Alla conoscenza di questi uomini veniva affidato il compito di costruire un’arma possibilmente capace di annientare il mondo e la decisione sull’opportunità di sganciarla.
Già il viaggio interdimensionale di “Interstellar” (2014) aveva scavato nel profondo di quella tendenza della scienza e dei suoi pionieri che la bioetica contemporanea aveva definito playing God, quella convinzione della coscienza di essere nella verità della cosa che le aveva dato la presunzione di potersi sostituire a Dio.
Non lo so e non importa; di diverso da Dio c’è l’impossibilità di conoscere l’interezza dell’Assoluto, di uguale, la convinzione di agire secondo giustizia; contro o nonostante l’Assoluto, questo non è importante.
Ma quando la scienza diventa un giocare ad essere Dio?
Lo spiega in modo estremamente efficace Massimo Cacciari nel breve saggio pubblicato per Adelphi, “Il lavoro dello Spirito” (2020): il fattore fondamentale che caratterizza il primo Novecento è la centralità del lavoro scientifico come mezzo privilegiato di accesso alla natura.
Il genio leonardesco - spiega Cacciari - lascia spazio all’ingegno specialistico che ha come base le scienze matematiche e geometriche, ma che si evolve grazie alle discipline derivate fino a coprire, anche se frammentandolo, l’intero spazio dello scibile.
Il titolo del libro è la traduzione letterale (Die Arbeit des Geistes) del titolo che Max Weber avrebbe dovuto dare alla trascrizione di due conferenze, poi uscite in pubblicazioni separate, tenute a Monaco di Baviera nel 1917 e nel 1921; la prima, La scienza come professione, ci offre una chiave d’accesso fondamentale a quell’atteggiamento scientifico che Cacciari avverte quale prima e principale conseguenza dell’era post-idealistica; la professione (Beruf in tedesco) della scienza – questo sembra dirci Weber – consiste nel razionalizzare l’idea, quel principio motore del mondo umano che la filosofia idealista e, su tutti, la filosofia di Hegel aveva posto a fondamento dell’umano stesso. Razionalizzare, quindi riportare le categorie del pensiero a modelli che sia possibile convertire in leggi, arrivando addirittura a cercare di eliminare il caso.
Il lavoro scientifico diviene il lavoro sull’idea, sul principio fondante la natura; in altre parole, la conoscenza del vero passa per la scienza e per i suoi protagonisti.
Allo scienziato viene concesso un onore che, in origine, era appartenuto solamente al profeta: la parola ultima sulla verità del reale. E non solo.
L’era contemporanea e gli organi di governo che la strutturano, inizia ad affidare alla scienza il suo bene sociale e politico più prezioso: il benessere della comunità.
Che questo si identifichi con la pace di un mondo in guerra o con la salvezza di un pianeta ormai prossimo alla fine, la restituzione di quel Bene che l’uomo aveva pensato come destinatogli per natura spetta al lavoro della scienza.
Ma qual è il limite di un tale mandato a favore (o a danno?) della realtà e quale il prezzo?
Lo scienziato - spiega Cacciari - diviene l’unica figura non vincolata da nessun affare che non sia la verità, diviene il più alto operatore di quel lavoro dello Spirito che la modernità aveva inteso come cammino di conoscenza della coscienza umana e collettiva.
Nessun condizionamento, certo, a parte sé stessi.
È questa la contraddizione che sembra rappresentare Christopher Nolan nel giovane Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy e in un meraviglioso Michail Caine nei panni dell’anziano scienziato di Interstellar.
Il prezzo è l’infinità della Vita (umana e naturale) racchiusa nelle mani tremule del singolo, un singolo annebbiato dalla propria presunzione, con l’anima infestata dai propri fantasmi al quale viene dato il permesso di fingersi Dio. Il limite - ancora una volta in modo contraddittorio - è la realtà intera.
C’è solamente un pericolo peggiore del finito che si crede infinito, dell’uomo che si crede Dio, quell’uomo che ne riconosce il rischio e lo corre; lo capisce l’Einstein di Nolan in un dialogo finale che sfiora l’intensità della poesia, lo aveva capito il vero J. Robert.
“Sono diventato morte, distruttore di mondi”; nella famosa citazione dal Bhagavad Gita pronunciata dallo scienziato americano a seguito delle operazioni contro Hiroshima e Nagasaki sembrano riecheggiare le parole dette da Mefistofele ad un Faust già troppo convinto della propria infinita potenza: “Sono una parte di quella forza che eternamente vuole il male e che eternamente opera il bene”.
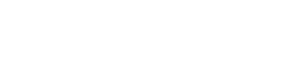




 amministrazione
amministrazione