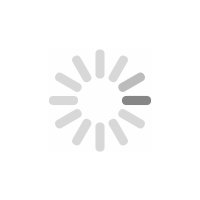Le parole gonfie di dolore di Guido Cecchettin al funerale della figlia Giulia, assassinata dall’ex fidanzato lo scorso 11 novembre, ci mettono di fronte a una verità sconvolgente nella sua potenza: «l’amore vero non uccide». Questa frase, semplice, scarna nella sua estrema dignità, ci permette di trascendere dolorosamente il caso di Giulia Cecchettin, così come la spinosa questione della violenza di genere; prendere in prestito queste parole sofferte, ci permette di ampliare ancora lo sguardo, di guardare all’uomo, ‘uomo’ non come termine indicatore di un genere, non ‘uomo’ come nome di una specie, bensì ‘uomo’ in quanto cornice di quell’umanità cui Hegel aveva dato il nome di ‘autocoscienza’, volendo indicare l’infinita capacità della coscienza umana di farsi consapevole di sé e del mondo che abitava.
Nel 1927 Martin Heidegger pubblicava “Essere e Tempo”, un’opera destinata a influenzare profondamente la riflessione filosofica contemporanea e, lo vedremo, non solo quella.
Nella complessità di un testo impossibile da riassumere in queste righe, un passaggio è tornato alla mia mente in questi tempi bui per l’umanità intera: la categoria della cura come essenziale costituzione dell’Esser-ci, ossia dell’Essere – nel – mondo come autocoscienza, dell’essere, appunto, umani.
Avere cura – scriveva Heiddeger – era la necessaria conseguenza della presa di coscienza della propria costitutiva manchevolezza, il necessario aprirsi all’Altro da sé per tentare di colmare la spaccatura dell’umano.
Ancor più del passaggio heideggeriano in sé, sono riaffioriate alla mia memoria alcune delle profonde riflessioni morali che declinarono “Essere e tempo” in una forma spesso poco gradita al suo autore, su tutte quella di Ludwig Binswanger.
Probabilmente poco noto ai più, Binswanger fu tutt’altro che un personaggio secondario del Novecento: psichiatra affermato, direttore sanitario della famosa clinica psichiatrica Bellevue di Kreuzlingen, egli fu anche un pensatore raffinato e il massimo esponente della cosidetta “psichiatria fenomenologica”. Colpito e, in una certa misura ispirato, dalla filosofia di Martin Heidegger, Binswanger intuì (non con poche critiche da parte dell’autore di “Essere e tempo”) l’importanza di declinare da un punto di vista clinico, ma anche morale, la categoria della cura.
Quella che Heidegger considerò una semplificazioned del proprio pensiero, e cioè il riferirsi all’umano, all’Esser-ci, essenzialmente come essere - nel - mondo, come uno stare nel mondo e con gli Altri, fu la chiave d’accesso a ciò che al medico svizzero stava più a cuore: la ragione di forme deviate, maniacali, patologiche di esistere.
In scritti fondamentali che rimangono ancor oggi attuali ed efficaci per la lettura di molti dei fatti di cronaca più recenti, Binswanger capisce che l’angosciante mancanza che costituisce l’uomo è anche ospite di infinte possibilità di autodefinizione e autocomprensione; avere cura, aprirsi all’Altro da sé nell’idea che questi sia la soluzione e il completamento del nostro essere dimezzati – come lo aveva chiamato Italo Calvino - è l’unica possibile via di dare all’Esser-ci, all’esistenza umana, la forma adeguata.
Il Novecento – e questo è chiaro già ad una prima e superficiale analisi delle sue forme espressive - si era trovato a fare i conti con la lacerazione, con la lacerazione di quell’umano che voleva disperatamente essere sé stesso, che ritagliava per sé un ruolo centrale nella realtà, ma che per natura si scopriva interrotto, spezzato, violentemente «fatto a brani».
Con acume degno dei più raffiinati pensatori, Ludwig Binswanger si era reso conto che alcune forme di mania che sfociavano nella violenza più efferata, non erano che “Forme di esistenza mancata “– per ricalcare il titolo di un suo importante scritto -, ossia modalità distorte, deviate, di rapportarsi agli Altri.
Il rifiuto terrorizzato di fronte all’incommensurabilità della manchevolezza genera delirio, il delirio di onnipotenza di chi considera la propria modalità di esistere, di amare, di credere, l’unica accettabile o il delirio di chi considera l’alterità una potenziale minaccia all’essere infinitamente certi, forti e conchiusi in sé stessi.
Là dove l’uomo riduce il rapporto con il prossimo a commercio, là l’esistenza fallisce.
Non c’è una malattia, una devianza connaturata nella lacerazione, il patologico alberga nell’indisponibilità del singolo di accettare la comunanza con l’Altro; in quella che Binswanger chiavmava brillantemente “esaltazione fissata” è oggi facile ritrovare le forme di narcisismo violento, di sopruso di genere, di classe o di appartenenza cui vengono spesso riportati i protagonisti delle più oscure pagine di attualità. La patologia – scriveva il medico svizzero – si nasconde nell’apparente normalità di chi di rifiuta di «percepirsi orizzontalmente», come una parte piccola e spesso marginale del Tutto, nell’umanità che si sente «salire verticalmente verso il cielo», tanto al di sopra della reltà da volerla dominare o - che è ancora peggio,- da volerla ridurre a propria emanazione e oggetto.
Il Settecento tedesco aveva teorizzato la necessità di un sistema di educazione culturale, sociale e lo aveva riassunto sotto la denominazione di kultur, aveva cioè compreso che l’umanità stava facendo della singolarità che la costruiva l’inizio e la fine della realtà intera e aveva l’urgenza di frenarne o comuqnue ostacolarne la conseguenza estrema: una comunità che iniziasse a percepirsi come il campo di battaglia tra le infinite totalità personali in costante e continua contraddizione.
Alle voci eminenti del Romanticismo tedesco, così come a quelle novecentesche nostre compagne in queste righe, si era, però, palesata anche l’impossibilità della coscienza di frenare la violenza che le riconoscevano propria e la fatica della singolarità nel rinunciare alla certezza di sé medesima; basti pensare allo stesso Heidegger, convintamente legato (almeno nella fase iniziale) alla causa nazionalsocialista, legato - conspevolemte o meno non sta a noi deciderlo – a quel sistema sì culturale e sociale che portò ad uno dei più grandi orrori della storia.
L’amore non uccide, ma l’uomo continua a farlo.
Nell’incapacità di riconoscere l’Altro come completamento della propria natura manchevole e finita, e non come strumento di soddisfazione dei propri desidere e delle proprie proiezioni, nella violenza che si finge amore – ‘amore’, termine che a questo punto potremmo considerare un sinonimo di ‘cura’, di apertura all’altro da sè -, nel narcisismo che si ritiene detentore di giustizia e verità, nell’ “esaltazione fissata” che vuole proteggere la propria nulla potenza, nella violenza di genere, nel razzismo e nell’omofobia che percorrono al galoppo le nostre strade, nel sopruso di uomini su altri uomini, muore l’umanità intera.
Nell’oscurità dell’abisso nel quale mi sembra intrappolata l’umanità, non resta che sperare che non si spenga mai la luce calda della coscienza, «perché bellezza e sapienza e giustizia sono solo in ciò che è fatto a brani».
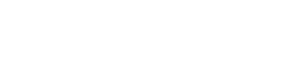




 amministrazione
amministrazione