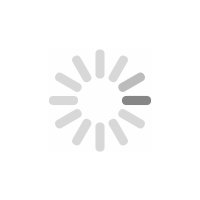L’attuale dibattito politico sui temi economici, incentrato sugli effetti dell’aumento dei prezzi sui salari e sui profitti, rievoca un noto saggio di Karl Marx, il cui titolo riprendeva proprio i tre termini della questione (Salario, prezzo e profitto, 1898). Questo saggio, seppure condizionato dalla visione marxista del valore-lavoro, secondo cui solo il superamento della forma capitalista di lavoro salariato avrebbe potuto contrastare efficacemente lo strutturale sfruttamento del lavoro, conteneva in realtà uno straordinario incitamento alla contrattazione. Marx, infatti, confutava la tesi, diffusa all’epoca, secondo la quale era inutile tentare di innalzare i salari reali, perché un aumento dei salari nominali si sarebbe tradotto inevitabilmente in un corrispondente aumento dei prezzi, riportando i salari reali al loro punto di partenza.
Marx sosteneva, al contrario, che l’aumento dei salari nominali non avrebbe necessariamente provocato un aumento dei prezzi ma bensì una riduzione dei profitti. E incitava pertanto i lavoratori a lottare per un aumento dei salari nominali, soprattutto nelle fasi di ciclo favorevole: “Se durante le fasi della prosperità, allorché si realizzano extraprofitti, egli [il lavoratore] non ha lottato per un aumento dei salari, non riuscirà certamente, nella media di un ciclo industriale, a mantenere neppure il suo salario medio, cioè il valore del suo lavoro.”
Sembrerebbe mero buonsenso sindacale, se l’esperienza italiana degli ultimi 50 anni non mostrasse quanto si sia discostata da questa visione la prassi negoziale che ha visto, anche nelle fasi di prosperità, sacrificare la contrattazione sui salari al perseguimento di obiettivi di legittimazione politica e di ambiziose quanto inconcludenti riforme di sistema.
Questa riluttanza a impegnarsi in una vera contrattazione sui salari sta raggiungendo l’acme nelle recenti posizioni della sinistra italiana, sia nelle sue forme politiche (il PD), sia in quelle sindacali (la CGIL), tutte orientate a chiedere allo Stato di risolvere il problema redistributivo tra salari e profitti attraverso interventi pubblici: l’imposizione per legge di un salario minimo e la richiesta di una tassazione straordinaria dei cosiddetti extra-profitti.
Né l’una né l’altra misura sembrano in grado di influire positivamente sul problema strutturale dei bassi salari.
La prima, sul salario minimo, i cui contorni restano peraltro fumosi, costituisce al più un intervento assistenziale su situazioni di particolare debolezza sociale, i cui effetti sul sistema complessivo dei salari sarebbero probabilmente nulli, se non controproducenti. I problemi applicativi sono poi quasi insormontabili: come stabilire il livello del salario minimo? Come tener conto del diverso costo della vita nelle diverse aree geografiche (nord-sud ma anche città-campagna)?
La seconda, la tassazione degli extra-profitti, rappresenta una esplicita rinuncia alla contrattazione. Quest’ultima, invece, dovrebbe essere la vera risposta, come diceva Marx, a una situazione di profitti superiori ai livelli “normali”. Invece che approfittare di una congiuntura favorevole per consentire anche al lavoro di beneficiarne, l’invocazione di una extra-tassazione affida le aspettative di redistribuzione a uno Stato sempre più inefficiente nella prestazione dei servizi sociali, che potrebbero invece essere oggetto di contrattazione nell’ambito di un ben più concreto welfare aziendale di natura negoziale e non lasciato alla sola benevolenza della parte datoriale.
Né d’altra parte il problema dei bassi salari può essere affrontato a lungo ricorrendo allo sgravio contributivo sui redditi da lavoro dipendente che, nonostante il supporto entusiastico bipartisan, non è altro che un sussidio mascherato, foriero di un ulteriore appesantimento della finanza pubblica e di uno squilibrio strutturale nel sistema previdenziale, poiché spezzerebbe il legame tra contributi e prestazioni.
L’ennesimo esempio di “gettare la palla in tribuna” è infine il referendum, promosso dalla CGIL e sostenuto dalla Schlein, contro il Jobs Act. Al di là degli intenti anacronistici se non controproducenti del referendum abrogativo, che prevede tra l’altro il ritorno del famigerato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e la sua estensione alle imprese sotto i 15 dipendenti, l’iniziativa della CGIL conferma l’approccio rinunciatario di quel sindacato a svolgere la propria funzione, cioè la contrattazione, per spostarsi sempre di più sul piano del partito politico, adottando un’agenda legislativa invece che rivendicativa. Ancora una volta, ci si affida allo Stato e alle sue leggi, manipolate attraverso un referendum solo apparentemente abrogativo, per sopperire alla mancanza di progettualità e di iniziativa contrattuale. Marx, almeno fino al compimento della rivoluzione, non avrebbe certamente acconsentito a una rinuncia così plateale al ruolo rivendicativo dei lavoratori: “se la classe operaia cedesse per viltà nel suo conflitto quotidiano con il capitale, si priverebbe essa stessa della capacità di intraprendere un qualsiasi movimento più grande”. Ma forse la CGIL e i suoi coriferi pensano di aver già avviato l’assalto al palazzo d’inverno.
(da isril.it )
(© 9Colonne - citare la fonte)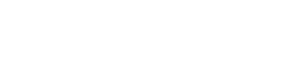




 amministrazione
amministrazione