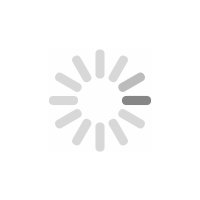Cosa lega la recente inchiesta milanese sul caporalato nel settore dei fattorini metropolitani e quella, sempre della Procura di Milano, di qualche mese fa, sui brand della moda? Il legame sta nel medesimo fenomeno giuridico-economico che, per correntezza, si definisce “caporalato” e che allude ad una sorta di scissione fra chi utilizza effettivamente il prodotto dell’attività lavorativa e chi appare come datore di lavoro.
Il fenomeno è antico se si pensa che una prima scarna regolamentazione è contenuta nel codice civile, che, come si sa, rimonta al 1942, in epoca fascista, che è però riferita ad una specie molto particolare e su cui non merita soffermarsi (il c.d. “cottimo collettivo autonomo”).
Invece un primo e davvero importante intervento è da farsi risalire ad una legge del 1960 (erano gli anni del New Deal del diritto del lavoro) che introdusse il fondamentale principio per cui il beneficiario finale del lavoro va considerato datore di lavoro, a prescindere dal soggetto che appaia come tale. In sostanza con quella legge venne codificata la regola per cui se un datore affida ad una finta impresa l’esecuzione di opere o servizi deve essere considerato il vero datore, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di obblighi relativi. E per finta impresa – appunto il “caporale” – si intende un soggetto che non abbia una struttura vera (la legge parlava di “capitali, macchine ed attrezzature” con riferimento alla tecnologia dell’epoca) per eseguire l’appalto, ma si avvalga soltanto dello sfruttamento del lavoro: di qui l’espressione “appalto di pura manodopera”. Si tratta di principi che ancora ci governano nonostante l’avvenuta abrogazione della legge del ’60, perché recepiti nei loro profili essenziali in provvedimenti più recenti.
La particolarità rispetto al fenomeno dei riders è che, in questo ambito, è la piattaforma che in qualche modo si presenta come “caporale”, dal momento che funge da interposto fra la proprietà ed i singoli lavoratori. Ed è ancora la piattaforma che impartisce le disposizioni di lavoro, premia e punisce ... e non continuo perché ne abbiamo parlato su queste colonne qualche tempo fa. E su queste colonne abbiamo ribadito che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di lavoro subordinato (come stanno riconoscendo pacificamente i nostri giudici) o comunque di una forma di collaborazione, coordinata e continuativa, cui si applica il diritto del lavoro.
Leggermente diverso è il caso dei brand della moda. Sempre la Procura di Milano ha infatti chiesto l’amministrazione giudiziaria, ad esempio, per Tod’s s.p.a. (ma anche per altri), con l’accusa di aver agevolato “fenomeni di caporalato” nella propria filiera tramite subfornitori cinesi tra Lombardia e Marche. Le indagini hanno rivelato lavoratori retribuiti 2,75 euro l’ora, turni notturni, macchinari insicuri e lavoratori alloggiati negli stessi opifici in condizioni igieniche precarie. Nella specie, senza contestare una responsabilità diretta, la Procura ha imputato ai marchi della moda una vigilanza debole sui propri subappalti.
In casi del genere le imprese si difendono allegando codici etici, rigorosi sistemi di controllo interni e, nella sostanza, l’impossibilità di inseguire l’intera filiera del lavoro.
C’è però un aspetto economico-giuridico della questione che viene sempre trascurato. Come si fa a trincerarsi dietro il “non potevo sapere”, in presenza di sistemi nei quali le gare promosse dai singoli brand sono al massimo ribasso e un capo prodotto viene venduto a prezzi trenta o quaranta volte superiori rispetto al costo pagato al singolo laboratorio artigiano? Per avere vivida consapevolezza di questa realtà del sistema economico contemporaneo basta ricordare la figura del bravissimo sarto napoletano Pasquale, nel film “Gomorra” di Riccardo Garrone (film del 2008), che dopo essere stato costretto (va da sé dalla camorra) ad accettare la confezione di abiti per un noto marchio della moda per trenta euro a pezzo, scopre, guardando la televisione, che una diva di Hollywood indossa un abito che lui stesso aveva confezionato e che veniva venduto – non c’è bisogno di dirlo – a prezzi esorbitanti.
Di fronte a questi fenomeni lo Stato che fa? Ci si aspetterebbe che incrementasse i controlli ispettivi sull’impiego del lavoro nelle filiere della moda come nella ristorazione a domicilio. Invece ho di recente ascoltato un importante esponente della maggioranza, con incarichi ministeriali di responsabilità, lanciare un appello “etico” ai consumatori, considerati i veri responsabili del fenomeno di sfruttamento, anche solo perché, testualmente, “non si alzano dal divano” per andare al ristorante o, nel caso in cui utilizzino le piattaforme, “non allungano una cospicua mancia al rider”.
È uno dei tanti modi di cavarsi d’impaccio e non ammettere le proprie responsabilità di fronte a fenomeni che non si riesce in alcun modo a governare.
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
(© 9Colonne - citare la fonte)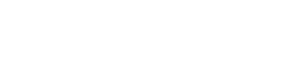




 amministrazione
amministrazione