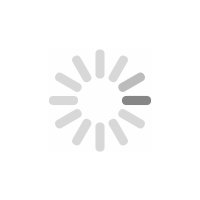(13 luglio 2018) La politica italiana continua ad essere ingabbiata entro la cornice della sfida populista. Non è possibile attribuirne la colpa al solo Salvini, sebbene sia il personaggio più attivo nel promuoversi in questo ruolo. Molti, se non proprio tutti (ma le eccezioni sono poche), lo seguono su questo terreno: un po’ perché una quota della attuale classe politica si è formata più che altro in quei “bar sport digitali” che sono i cosiddetti social; un po’ perché anche in personaggi che dovrebbero essere più sperimentati prevale la convinzione che oramai solo così si trova audience.
Chi si sottrae, magari perché non ha la stoffa per quel genere di intemerate, si guarda bene dal mettere in discussione quel contesto comunicativo. Lo si è visto in maniera più che chiara nell’intervista che il presidente Conte ha rilasciato alla “Stampa” il 10 luglio: un avvocatesco approccio per dire che in fondo era d’accordo su tutto quel che facevano i suoi due vice, Di Maio e Salvini, e se parlava poco era perché studiava i dossier (a qual fine non è chiaro).
Il fatto è che in un equilibrio ancora precario continua a dominare la voglia di tenere “caldi” i rispettivi elettorati, fosse mai che si dovesse tornare alle urne, e comunque in vista di quelle inevitabili delle elezioni europee. Del resto nessuno crede che nel paese ci sia una domanda concreta di “governo” e si pensa piuttosto che sia necessario coltivare le differenti attese miracolistiche di cambiamento mosse dalle inquietudini verso un futuro che continua a presentarsi come incerto.
Colpisce che le opposizioni, per quanto deboli, non sappiano produrre visioni alternative, ma siano piuttosto unite dall’attesa, anch’essa miracolistica, di un ritorno dell’elettorato ai vecchi ovili. Vediamo di analizzare un poco questa relativamente strana situazione.
Il moderatismo di centrodestra continua ad essere incarnato dal più che vecchio Berlusconi, perennemente convinto di essere in grado di “fare la differenza” con la sua sola presenza personale. In realtà ha perso la capacità che un tempo pure aveva di mobilitare delle aspettative, per mirabolanti che siano state. Oggi si limita a profetizzare catastrofi a seguito della gestione dell’attuale maggioranza, a ripetere lo stanco ritornello su Di Maio che non ha mai lavorato, a richiamare Salvini alla fedeltà all’alleanza con i ceti produttivi che ritiene ancora di rappresentare. Nonostante qualche sforzo di presenza verso i ceti dirigenti (si vedano le sue ripetute “lettere” al “Corriere”), un ritorno al maquillage del gruppo dirigente di FI (Tajani promosso ad una posizione di vice-leader), una ventilata ipotesi di ritorno diretto nella contesa elettorale, l’ex Cavaliere non è percepito come un elemento in grado di scuotere davvero l’apatia del suo antico mondo di riferimento.
Qualcosa di simile va detto per colui che volle essere ed effettivamente fu per un certo periodo l’alternativa governante da sinistra al tardo berlusconismo, e cioè Matteo Renzi. Il suo intervento alla direzione PD del 7 luglio ha rivelato un populista ormai sfiatato, capace solo di distribuire veleni verso gli altri senza avere alcun progetto alternativo da presentare che non fosse una sua ipotetica resurrezione, anche qui sullo sfondo di un profetizzato fallimento dell’alternativa giallo-verde. I dieci punti con cui ha cercato di spiegare il tonfo elettorale del suo partito non sono stati per nulla convincenti, perché in sostanza ripetevano un ritornello populista: abbiamo perso perché eravamo “algidi”, non abbiamo saputo concentrarci a sostenere un solo leader (lui, ovviamente), basterà cambiare su quei terreni e torneranno i tempi d’oro.
La sua chiamata alle armi di tutti quelli che lui ha portato ai ruoli direttivi è suonata come la replica di quanto fanno tutti i condottieri che si vedono incamminati sul viale del tramonto: può darsi che gli garantisca qualche successo nelle lotte tribali del partito, è altamente improbabile che gli rendano le antiche legioni di elettori.
Tuttavia è realistico registrare che non ha avuto oppositori di peso. Zingaretti è ancora lì a riproporre la storiella del “si vince unendo la sinistra”, come se ormai non ci si rendesse conto che non è raccogliendo un po’ di superstiti delle patrie battaglie di un tempo che si potrà sperare nel successo in una guerra moderna, cioè con tutt’altre coordinate rispetto a quelle del passato. Gli avversari moderatamente renziani del presidente della regione Lazio evocano in lui una prospettiva “alla Corbyn” e non sono lontani dal vero, ma non è più che una brillante battuta di polemica politica. Rimane il fatto che il PD continua ad essere incapace di rigenerare le sue cellule pensanti, né più né meno come Forza Italia.
In queste condizioni non c’è da aspettarsi molto di buono. L’assenza di una opposizione in grado almeno di erodere il consenso dei giallo-verdi non spinge certo il governo a moderarsi passando ad un approccio più realista nell’analisi della difficile situazione in cui si trova l’Italia nel quadro di un contesto europeo e non solo profondamente in subbuglio. Al più si può contare sull’opera di contenimento che, grazie ad un po’ di furberie, può venire da qualche ambiente dei ceti dirigenti: alta burocrazia, qualche potere economico, qualche “tecnico” prestato al governo (leggi: Tria), qualche centro decisionale internazionale. Un po’ poco per stare tranquilli, ma soprattutto nulla che possa mettere a freno il perdurante dilagare dell’orgia di populismo che continua imperterrita a fare danni nel quadro della formazione del consenso politico nazionale.
/da mentepolitica.it)
(© 9Colonne - citare la fonte)
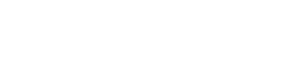



 amministrazione
amministrazione