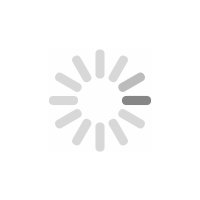(6 novembre 2018) Scorrono i classici fiumi di inchiostro sulla crisi delle sinistre in Europa e l’Italia non può certo presentarsi come una eccezione. In Germania si parla, da qualche tempo, di una crisi dei Volksparteien, cioè dei partiti “di popolo”: la traduzione in “partiti di massa” è a nostro avviso imprecisa, perché invece si tratta proprio della crisi di poter avere dei partiti che rappresentano “tutti”. Si può magari pensare che ciò sia strano mentre imperano populismi che tendono a presentare come “del popolo” qualsiasi loro scelta, dai bilanci pubblici alla lotta contro le grandi infrastrutture.
In realtà la cosa è più complicata, e vale la pena di cercar di capirla. I partiti “popolari” non erano nella loro struttura populisti, ma, per usare un vecchio linguaggio, interclassisti. Supponevano cioè di essere capaci di rappresentare le diverse componenti da cui era formato il popolo, armonizzandole e portando a sintesi le rispettive esigenze. Il politologo tedesco, a lungo emigrato in America, Otto Kirchheimer inventò a metà anni Cinquanta la formula del “catch all party”, il “partito pigliatutto”: guarda caso lo fece contrapponendo la CDU che era interclassista alla SPD che in quella fase voleva ancora essere un partito operaio. Ma ben presto anche la SPD, sotto la guida di Willy Brandt, scelse esplicitamente di essere un partito “popolare” anziché di classe.
Questa dinamica fu, pur con tempi e variazioni diverse, seguita da tutti i grandi partiti europei, finché accadde, negli ultimi tempi, che andasse in crisi l’idea del popolo come sistema pluralistico di componenti però fortemente interconnesse. Per riprendere una acuta definizione del filosofo politico Pierre Rosanvallon nel suo ultimo libro (Notre histoire intellectuelle et politique, Seuil 2018), dipende dalla trasformazione dell’individualismo: si è passati dall’“individualismo di similitudine”, quello che rinvia ad una qualche forma di partecipazione a delle universalità, all’ “individualismo di singolarità” dove ciò che determina il singolo non è la sua condizione, ma la sua storia personale. In questi contesti il popolo non è più una pluralità di raggruppamenti sociali, ma una astrazione che riunisce una infinita singolarità di individui che vengono “assemblati” attorno a qualche slogan e/o proposta che si vuole sia comune a tutti pur lasciando ciascuno nella sua solitudine. E chi non è assemblabile attorno a questo supposto “comune sentire” non sarebbe semplicemente degno di essere preso in considerazione come membro del popolo.
Non sembri un ragionamento troppo accademico. Si tratta di una dinamica che sta attirando nel suo gorgo, con diverso successo, tutte le forze politiche in campo in Europa, ma anche in Italia. Quelle tradizionali fanno fatica a capire i tempi nuovi, perché le loro classi dirigenti sono state educate a pensare nei vecchi termini. Quelle di più recente formazione, oppure quelle dove si è riusciti davvero a percepire il mutamento di contesto, viaggiano al momento col vento in poppa.
Naturalmente è patetico vedere vecchi e nuovi leader delle forze di tradizione che cercano di accreditarsi come populisti non essendo in grado di ridare senso a quell’essere “popolari” che avevano da tempo abbandonato. L’Italia offre un buon esempio da questo punto di vista col PD i cui dirigenti si affannano ad inventarsi immersioni nella società civile: si va da Renzi che riscopre i “comitati civici” ad altri che propongono “listoni” imbarca tutti per le prossime elezioni europee (ma stanno pensando anche a quelle locali).
Sembrano non rendersi conto che la questione non è inventarsi nomi nuovi, ma disporre di proposte che almeno appaiano in grado di stendere un mantello unificante sulle singolarità disperse prodotte dalla nostra società in transizione. I populisti veri lo fanno usando a questo fine un mix di presunte prese in carico delle paure di fronte al nuovo e di promesse che il nuovo non arriverà perché si riuscirà a mantenere in vita il tempo delle vacche grasse. I neopopulisti dilettanti della sinistra che non possono platealmente copiare quelle ricette (lo fanno in maniera pasticciata e per questo non convincente), si inventano una rincorsa alla coalizione delle “maschere” che nel loro retaggio dovrebbero rappresentare quel popolo pluralista delle condizioni sociali.
Così però non è. Le “maschere” sono prodotti della politica spettacolo e quando scendono dai palcoscenici mediatici per contattare il mondo reale diventa evidente l’inconsistenza della loro rappresentazione. I “comitati civici” non hanno funzionato come produttori di classe dirigente duratura neppure quando cercavano di radicarsi in organizzazioni di massa come quelle cattoliche degli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, figurarsi se può farli rivivere qualche dirigente che non si sa di quali accreditamenti possa disporre anche per realtà assai più modeste. Quanto ai “listoni” gli assemblaggi fra vecchi ceti dirigenti di movimenti in disarmo e un po’ di maschere pescate dai talk show non fanno storia e portano poco lontano: riflettere sulla vicenda di Forza Italia per rendersene conto (e ricordarsi che le condizioni favorevoli dei suoi tempi di esordio non esistono più).
Se si vuole seriamente cercare un’alternativa al successo attuale dei populismi bisogna lavorare in altre direzioni ed essere disposti alla fatica e ai tempi non brevi che l’operazione richiede.
(da mentepolitica.it)
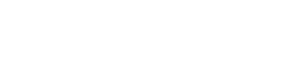



 amministrazione
amministrazione